

GRAMSCI A TURI E IL PARTITO
(1928/1933)
(presentazione di Ferdinando Dubla - testimonianze di Giovanni Lai, Sandro Pertini, Angelo Scucchia, Bruno Tosin)
La detenzione di Gramsci a Turi fu dolorosa non solo per l’aggravarsi delle condizioni di salute del detenuto, ma anche per le difficoltà di rapporto con il partito. Difficoltà oggettiva: i detenuti politici che venivano inviati alla casa penale, dopo poco tempo venivano trasferiti dalla direzione del carcere per impedire a Gramsci di comunicare con il proprio partito tramite intermediari. Ma alla difficoltà oggettiva si intersecò la difficoltà tutta politica dell’interpretazione della linea politica del PCI, nonostante continuasse la campagna internazionale per la sua liberazione tramite il “Soccorso Rosso” e un Comitato parigino presieduto da Roman Rolland ed Henry Barbusse, che ebbe un’impennata nel 1933. Il VI Congresso del Comintern, che si era tenuto dal luglio al settembre 1928, aveva posto come base analitica la categoria di "fascistizzazione della socialdemocrazia" e della dura battaglia da intraprendere contro l'opportunismo che, con il riformismo, rischiava di penetrare nelle fila del movimento operaio: la lotta contro la socialdemocrazia e il fascismo diventa, per i comunisti, tutt'uno. Le indicazioni cominterniste saranno confermate al X Plenum nel luglio 1929. In Italia, il mese successivo, viene convocato l’Ufficio Politico e si inizia a manifestare un’opposizione, in particolare in merito all’organizzazione politica conseguente alla cosiddetta “svolta del terzo periodo”. La linea uscita dal X plenum, quella della crisi finale del capitalismo e della radicalizzazione delle masse, era quella da sempre propugnata dalla Federazione giovanile comunista (Fgc). Così è Longo ad elaborare tutta una serie di proposte tese a adeguare l’attività del partito alla politica dell’Internazionale, note come “progetto Gallo” (Gallo è lo pseudonimo di Longo), che trovano la massima espressione nella richiesta della ricostruzione di un centro interno. A questa ipotesi si oppongono Tresso, Leonetti e Ravazzoli che presentano un controprogetto, noto come “controprogetto Blasco” (Blasco è, all’epoca, il nome di battaglia di Tresso). I rapporti tra la maggioranza e l’opposizione degenerano in breve tempo fino alla espulsione dei “tre” (a cui si aggiunsero Teresa Recchia e Mario Bavassano) sancita nel Comitato Centrale del 9 giugno 1930 per essersi messi in contatto con i trotskisti, aver condotto una campagna calunniosa contro il Pci e per avere una “errata valutazione delle prospettive del regime fascista”.
Gramsci conosce poco di queste vicende; ma, come si era preoccupato già delle divergenze in seno al PCUS (il gruppo Trotzkij-Kamenev e Zinoviev e Stalin-Bucharin) con la celebre lettera al CC dell’ottobre del 1926 in cui si appellava all’unità derivante da un senso di responsabilità storico del gruppo dirigente sovietico, lettera mai inoltrata da Togliatti, che allora rappresentava a Mosca il partito italiano nell’Internazionale; così matura convincimenti forti sulla natura della fase politica italiana e si fa assertore di una “politica di transizione” dal fascismo al socialismo, passando per un’Assemblea Costituente e un’alleanza con le altre forze politiche antifasciste. Gramsci cerca di comunicare questa sua posizione, che intanto gli vale un progressivo isolamento, tranne l’assoluta fedeltà dei giovani comunisti Giuseppe Ceresa ed Ercole Piacentini e del socialista Pertini, ed incomprensioni dolorose nelle difficili condizioni carcerarie:
il 16 giugno 1930, attraverso il fratello Gennaro, che tuttavia non riferirà le sue effettive posizioni a proposito della "svolta" e dell'espulsione dei "tre", poi invitando Athos Lisa, amnistiato, che gli dice di essere ora convinto della giustezza della sua prospettiva, a battersi presso il Centro estero "per la linea politica da me enunciata". Ancora, incaricando Giuseppe Ceresa, anch'egli amnistiato, di riferire - se gli fosse stato possibile espatriare - al Centro estero le sue effettive posizioni sulla situazione italiana, ciò che Ceresa fa già nel corso del 1933 o più probabilmente del 1934. E infine, poco prima di morire, attraverso Pietro Sraffa, chiedendogli di "trasmettere la sua raccomandazione che si adottasse la parola d'ordine dell'Assemblea costituente”. Inoltre si proponeva, come si evince dal rapporto che Athos Lisa scrisse il 22 marzo del 1933 per il Centro del Partito appena uscito dal carcere di Turi, di formare nuovi quadri dirigenti comunisti fermi e determinati nei principi come nell’azione, ma contro il massimalismo sterile e dottrinario (il “soggettivismo dei sognatori”). Ha scritto Aldo Natoli:
“La fase piú acuta della crisi nei rapporti tra Gramsci e il partito, da non confondersi con una rottura formale o con l'interruzione dell'azione di solidarietà, si delinea negli ultimi mesi del 1932, per raggiungere il momento piú drammatico nel febbraio 1933: in questa crisi si intrecciarono inestricabilmente motivi politici e personali, il riemergere dei dubbi e delle ossessioni del passato (il significato nascosto nella lettera di Grieco del 1928) e il crescente senso di isolamento e anche di estraneazione di Gramsci nei confronti del Pcd'I, ma anche l'inarrestabile aggravamento delle condizioni di salute, il timore del venir meno delle proprie forze di resistenza, la sensazione dell'irreversibile dissoluzione dei rapporti con la moglie Giulia e dei legami familiari.” [in Gramsci in carcere, Studi Storici nr.2, aprile-giugno 1995].
La tensione pare sfoci anche in un episodio particolarmente grave: Gramsci nell’ora d’aria per un soffio non viene colpito da un sasso in fronte nascosto in una palla di neve. Ma chi fu a lanciare il sasso? A Turi nel 1933 sono rinchiusi numerosi detenuti politici, tre anarchici e diciotto comunisti; tra essi, Francesco Lo Sardo, Ezio Riboldi, Athos Lisa, Enrico Tulli, Giovanni Lai. Ma dalla testimonianza di Sandro Pertini, l’episodio, nonostante l’astio del comunista Scucchia, viene addebitato ad altri gruppi di detenuti, presumibilmente agli anarchici.
Le speculazioni sulla rottura tra il partito e Gramsci sono state fin troppe. In realtà l’evoluzione della situazione politica e sociale porterà proprio Togliatti a perseguire una politica gramsciana, dopo l’avvento del nazismo in Germania nel 1933 e dopo il VII Congresso del Comintern nell’estate del 1935 (i “fronti popolari”).
Fu il fascismo ad uccidere Gramsci. E fu il Partito Comunista di Togliatti, Longo, Secchia, Scoccimarro a renderlo vivo e non un’icona imbalsamata. E ancora oggi, queste stesse testimonianze, ce lo rendono ancor più vivo, come tutta la sua elaborazione e riflessione storico-politica e filosofica. Dal carcere di Turi, Bari, al mondo “grande e terribile”.
Vedi anche Giuseppe Fiori, Vita di Antonio Gramsci, Laterza, Roma-Bari 1966, e poi in Paolo Spriano, Gramsci in carcere e il partito, Editori Riuniti, Roma 1977, aggiornato in una nuova edizione a cura de “l’Unità” editrice, Roma 1988; A. Lisa, Memorie. Dall'ergastolo di Santo Stefano alla casa Penale di Turi di Bari, Milano, 1973; testimonianza di Ercole Piacentini riportata in Istituto Ernesto De Martino, Gramsci raccontato. 8 testimonianze raccolte da Cesare Bermani, Gianni Bosio e Mimma Paulesu Quercioli, a cura di Cesare Bermani, Roma, Edizioni Associate, 1987
GIOVANNI LAI
Dopo aver militato nel Partito sardo d'azione, nel 1923 entrò nel Partito comunista e fu chiamato a far parte del direttivo della sezione di Cagliari. Arrestato il 12 maggio 1927, dopo un periodo di segregazione cellulare a Lucca, venne mandato a Procida perché gravemente malato e poi a Turi di Bari dove trascorse 16 mesi. Il resto della condanna lo scontò a Lecce e poi a Civitavecchia: 5 anni e 6 mesi complessivamente. Rientrato a Cagliari, nel 1933 riprese contatti con l'organizzazione del partito. Fu arrestato ancora nel 1937 e fino al 1943 subì altri arresti e persecuzioni. È, stato segretario della federazione comunista di Cagliari dal 1944 al 1951, membro del comitato centrale dal V al IX congresso, consigliere regionale per quattro legislature. Su "Rinascita" del 20 febbraio 1965 apparve il suo scritto <Colloqui con Gramsci nel carcere di Turi>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ebbi la notizia del trasferimento da Procida qualche giorno prima della mia partenza, ma non mi fu comunicata la nuova destinazione. Solo quando fui sul vaporetto che fa servizio fra Procida e Napoli i carabinieri che mi scortavano mi dissero che ero destinato alla casa penale di Turi di Bari.
La notizia mi riempi di gioia giacché in quel carcere avrei trovato Gramsci. Poter stare con lui per qualche tempo era desiderio di tutti i compagni reclusi nelle carceri fasciste, ma a pochi era dato di poterlo realizzare.
Si diceva che Gramsci fosse molto malato e sofferente, che vivesse isolato, senza assistenza medica adeguata, in condizioni ambientali non adatte alle sue condizioni di salute e che di conseguenza la sua vita carceraria fosse difficile e tormentata. Si diceva anche che la vita del carcere, le sofferenze e le privazioni lo avessero reso irascibile e molto riservato e che non era facile stabilire con lui rapporti umani e politici. Nonostante avessi saputo tutte queste cose, ero felice di andare nel carcere dove egli si trovava.
Lo avevo già incontrato in occasione del convegno regionale dei comunisti sardi, che si tenne a Cagliari nel mese di ottobre del 1924; ma avevo potuto parlargli solo per pochi minuti. Era in compagnia di un figlio di Alberto Figus che in quel periodo era il responsabile provinciale del partito. Figus mi presentò a Gramsci come uno dei dirigenti più giovani della sezione di Cagliari; io lo salutai e gli porsi il benvenuto nella nostra città; la conversazione durò solo il tempo di bere un caffé, nel bar-pasticceria di Clavot in piazza Jenner, dove io lavoravo allora.
Gramsci mi fece una grande impressione. Non solo perché era la prima volta che mi trovavo in presenza del capo dei comunisti italiani, ma per il modo semplice con cui mi rivolse la parola e mi chiese notizie sulla vita e le attività del partito in Sardegna e in particolare a Cagliari.
Pure essendo deputato e capo di un grande partito, Gramsci aveva l'aspetto di un uomo comune, senza pretese; io sapevo però che era un personaggio di grande valore e che la stima e l'affetto di cui lo circondavano i compagni erano del, tutto giustificati. Al convegno tenne lui la relazione e la sezione di Cagliari seppe trarre profitto delle sue indicazioni politiche e di lavoro per far uscire il partito dalla condizione di isolamento in cui si trovava in Sardegna. Il parere unanime dei compagni fu che con un dirigente come lui alla testa del partito le cose sarebbero cambiate profondamente e si sarebbe finalmente imboccata la strada per la costruzione di un partito nuovo, capace di fare politica.
Questi ricordi mi vennero spesso alla mente durante il lungo viaggio di trasferimento da Procida a Turi di Bari. La mattina successiva al mio arrivo a Turi, dopo il disbrigo di alcune formalità che facevano parte della sistemazione di un detenuto nuovo aggiunto, — cosi si diceva nel linguaggio carcerario — e dopo aver sistemato le mie cose nella cella che mi era stata assegnata, fui condotto nel cortile "dei comunisti." Cosi era chiamato infatti il cortile dove i detenuti politici trascorrevano le ore d'aria.
Riconobbi subito Gramsci perché la sua figura mi era rimasta bene impressa nella mente, anche se erano passati molti anni da quando l'avevo incontrato a Cagliari. Passeggiava lentamente con altri due detenuti, quasi appeso al braccio di uno di essi, come per farsi sorreggere. I due, come seppi in seguito, erano due giovani operai milanesi con i quali Gramsci era legato da profonda amicizia.
Mi avvicinai e lo salutai. Ero impacciato, imbarazzato, nonostante fossi felice di trovarmi finalmente col capo riconosciuto e stimato del Partito comunista italiano, del quale tutti ormai parlavano con grande rispetto e considerazione
Gli dissi che ero sardo, di Cagliari, che lo avevo visto è conosciuto in occasione del convegno regionale del 1924 e allora fu molto affettuoso. Mi parlò in sardo, probabilmente per farmi superare lo stato d'animo d'imbarazzo in cui mi trovavo e che non gli era sfuggito. Mi pose una infinità di domande sui compagni sardi che aveva conosciuto, sulla situazione del partito in Sardegna, sui contadini, i pastori, i muratori, sul Partito sardo d'azione, su come avevo utilizzato il periodo di detenzione/sui compagni che avevo conosciuto in carcere e sul modo in cui questi compagni vivevano e studiavano.
Io risposi a tutto con la massima precisione, ma senza riuscire a liberarmi dello stato di soggezione in cui mi trovavo. Cosi cominciò a canzonarmi e mi disse che mi comportavo come un vecchio pastore sardo riservato e orgoglioso. E continuò su questo tono.
Nei giorni successivi mi ragguagliò sul clima politico e morale nel quale stavo per inserirmi e nel quale sarei vissuto per un certo periodo di tempo; mi disse che non
tutti i detenuti politici che vedevo erano comunisti, che c'era anche un gruppetto di anarchici con i quali i rapporti non erano facili poiché non partecipavano alle nostre conversazioni e vivevano isolati. Tra i compagni si parlava di politica e di problemi culturali nella misura in cui lo consentiva l'ambiente carcerario che costringeva tutti a una vita limitata e meschina.
Intuii che soffriva per l'isolamento a cui era costretto e per la limitatezza dei rapporti umani che il carcere gli imponeva. Più tardi, parlando con i compagni presenti a Turi, mi resi meglio conto che Gramsci era impegnato in una lotta continua per non essere sommerso e vinto dall’ambiente e dalla routine della vita carceraria; il suo precario stato di salute, le sofferenze, l'insonnia non gli impedivano infatti di leggere una grande quantità di libri, di riviste e di pubblicazioni che gli venivano fornite da varie case editrici, cosi come non gli impedivano di studiare e di scrivere durante le ore che trascorreva nella sua cella. Mi resi anche conto in seguito che nel corso delle conversazioni con noi — interessanti ed utili per la nostra formazione culturale —• egli ci sottoponeva per un giudizio critico il risultato delle sue riflessioni e dei suoi studi. Esponeva queste questioni in modo semplice e convincente e sempre sollecitava uri nostro intervento.
A differenza degli altri compagni detenuti, che erano sistemati a tre o quattro per cella, Gramsci stava da solo e poteva disporre dell'occorrente per scrivere. Questo era il solo privilegio di cui godeva; che poi non di un privilegio si trattava, ma di un diritto riconosciuto dal regolamento carcerario e del quale egli faceva buon uso. Per tutto il resto era soggetto alle norme del regolamento come qualsiasi altro detenuto, usufruiva del vitto speciale solo perché era affetto da gravi disturbi all'apparato digerente. Nessun privilegio, dunque, gli era riservato.
Del resto egli non chiedeva mai nulla che non gli spettasse per un diritto previsto dai regolamenti e ogni sua richiesta era avanzata tenendo conto di questi limiti. Non accettava privilegi e si irritava se qualcuno lo considerava vittima del fascismo. "I comunisti condannati dal tribunale speciale fascista non sono delle vittime, sono dei prigionieri in mano del nemico e al nemico non si chiedono favori. Siamo dei combattenti che hanno lottato e continuano a lottare anche se in condizioni difficili; e, pertanto, non chiediamo grazia al nemico di classe." Queste cose Gramsci le ripeteva ogni volta che sorgevano questioni fra le esigenze dei compagni e la rigidità del regolamento carcerario.
Poteva Gramsci essere accusato di eccessivo legalitarismo per questo suo atteggiamento dignitoso e coerente? Evidentemente no. Gramsci sapeva per lunga esperienza e per convinzione politica che l'agitazione a volte non cambia la realtà; e la nostra realtà era la vita del carcere con la quale bisognava fare i conti. Ai detenuti politici di Turi era riservato uno dei quattro cortili di cui il penitenziario disponeva e che solo loro potevano frequentare. Ma neppure questo era un privilegio. Era solo una scelta della direzione del carcere ed aveva uno scopo ben preciso: evitare che i politici, cioè i comunisti, potessero avere contatti con i detenuti comuni. Questa disposizione garantiva inoltre alla direzione la possibilità di esercitare una vigilanza più diretta e più stretta nei nostri confronti. La vita in comune tra Gramsci e gli altri compagni era limitata alle ore del passeggio del mattino e del pomerìggio.
Gramsci non rinunciava mai al passeggio: in inverno e in estate, fosse bello o cattivo il tempo, egli veniva giù in cortile. Perché solo in questo modo poteva stare con i compagni, poteva parlare e sentir parlare, poteva discutere le questioni sulle quali in solitudine aveva riflettuto a lungo, poteva confrontare le sue idee con quelle degli altri. Come ho già detto, egli cercava il dialogo con i compagni, insisteva perché esprimessero i loro pareri, anche se contrastanti con le sue idee. Tutto questo non lo faceva a caso, perché evidentemente egli si prefiggeva lo scopo di sviluppare in noi lo spirito critico e di arricchire la nostra preparazione culturale e politica.
Gramsci in cortile preferiva muoversi e intanto parlava con i compagni che gli stavano intorno. Camminava lentamente e parlava in modo pacato, ma a lungo, quasi preoccupato di non aver abbastanza tempo per renderci partecipi delle sue idee e delle sue riflessioni. Quel che più colpiva in lui era il modo semplice di parlare anche quando esponeva concetti e idee nuove, cosi riusciva a farsi capire anche dai compagni più modesti e impreparati. Esponeva i risultati delle sue analisi e le conclusioni a cui era giunto in forma semplice ma chiara, sempre tenendo conto delle difficoltà rappresentate dai limiti e dai diversi livelli culturali di un uditorio composito come era il nostro. Se quanto andava esponendo non veniva interamente compreso dai compagni non si spazientiva, non perdeva la calma. Riprendeva il discorso e lo arricchiva con immagini prese dalla vita reale, in modo da rendere più comprensibili quei concetti cosi difficili e nuovi per chi li udiva per la prima volta. Cosi la sua esposizione, oltre che interessante, diventava anche piacevole.
Per spiegare in modo semplice le difficoltà che incontrava la rivoluzione sovietica, e per illustrare nel suo difficile cammino il ruolo d'avanguardia della classe operaia ci disse: pensate ad un treno in marcia, ma un treno di tipo particolare. La locomotiva è potente e moderna, ma. ad essa sono agganciati tutti i mezzi di trasporto di cui l'umanità si è servita fin dalle sue origini, dai carretti primitivi e sgangherati che adoperavano i contadini russi nei più sperduti villaggi, ai vagoni moderni. La locomotiva deve trainare tutto il convoglio e non può correre secondo le sue possibilità, deve adeguare la sua marcia alla complessità dei mezzi che traina. La marcia è lenta, si verificano guasti e sganciamenti, gli operai della locomotiva e dei primi vagoni devono correre spesso a riparare i guasti che si verificano, a cambiare i pezzi che si sono rotti, ad agganciare i vagoni che si sono staccati. Devono stimolare continuamente tutti i viaggiatori a modifiche continue delle attrezzature e del materiale. Ma, a poco a poco, la marcia del treno si fa più sicura e più spedita e durante il viaggio tutti i viaggiatori si trasformano...
Questo modo di esporre rendeva più facile il rapporto tra i compagni e Gramsci e, poiché il numero dei comunisti detenuti a Turi era intanto cresciuto, nel mese di luglio del 1930 egli propose di organizzare le conversazioni in maniera più organica di quanto si fosse fatto prima di allora. Ci si radunerà in gruppo stando a sedere — disse — cosi la partecipazione dei compagni alla discussione potrà essere più impegnata e proficua.
Gramsci avrebbe esposto delle tesi sui temi politici e ideologici e su di esse si sarebbe aperta la discussione con la partecipazione di tutti. I temi sarebbero stati i seguenti: il fascismo e il suo carattere di classe, la funzione degli intellettuali nella società, la questione meridionale, la funzione del partito della classe operaia nella lotta per il socialismo, l'ipotesi di un periodo di transizione democratica dopo la caduta del fascismo, le forze motrici della rivoluzione in Italia.
Fu nel corso di queste conversazioni che espose l'idea dell'assemblea costituente. La convocazione di un'assemblea costituente come parola d'ordine capace di creare
le basi per una lotta unitaria della maggioranza degli italiani contro il fascismo.
Si tratterà di un pugno nell'occhio — disse. E non era solo una battuta. Con questa espressione intendeva forse , sottolineare il grande valore politico dell'idea e anche prospettare ai compagni le immancabili reazioni delle forze politiche italiane di fronte alla proposta di una costituente avanzata dai comunisti.
Parlò a lungo del partito nuovo; un partito capace di portare avanti la linea del rinnovamento politico, morale e culturale della società italiana, capace di realizzare le necessarie alleanze politiche e sociali, un partito con la forza, la capacità, e la volontà di intervenire nella vita nazionale come elemento determinante. Un partito della classe operaia, sempre consapevole della funzione della classe, ma anche grande forza nazionale, attento ai problemi irrisolti della società italiana, al Mezzogiorno, alla questione dei contadini. Un partito che contemporaneamente sappia mantenere i suoi legami col movimento internazionale.
Sulle tesi esposte da Gramsci discutemmo molto e con impegno e non mancarono posizioni contrastanti fra i compagni del nostro gruppo. Certo quello fu il periodo più interessante della nostra vita con Gramsci e credo non solo per me. Ma fu anche la fine di ogni conversazione organica e sistematica. La direzione del carcere intervenne bruscamente informando che gli assembramenti non erano consentiti; che, a norma di regolamento, durante il periodo dell'aria nei cortili all'uopo destinati, i detenuti dovevano camminare in silenzio, ognuno per proprio conto; o stare seduti sui sedili, ma evitando la formazione di gruppi.
Era una prima manifestazione di irrigidimento disciplinare alla quale se ne sarebbero aggiunte altre in seguito. Diversi compagni proposero di opporsi a queste disposizioni, ma Gramsci li contraddisse affermando che è sciocco proporsi di abbattere il muro a colpi di testa, perché il muro resta in piedi e la testa si spacca. La sua posizione fu questa: abbiamo fatto bene a fare ciò che abbiamo fatto perché lo ritenevamo utile e istruttivo, ma eravamo anche consapevoli che la cosa non sarebbe passata inosservata e che ad un certo punto saremmo stati costretti a smettere. Abbiamo forzato la mano, ma sapevamo che non avremmo potuto continuare per molto tempo. È evidente che nel momento in cui la direzione interviene richiamandoci al rispetto delle norme carcerarie, noi non possiamo fare altro che interrompere l'attività intrapresa. Che altro potremmo fare? La maggior parte dei compagni convenne che la soluzione non poteva essere che quella espressa da Gramsci, ma ci furono anche quelli che sostennero che bisognava continuare comunque. Alla fine fu deciso di interrompere quella forma di attività e di riprendere le conversazioni nella vecchia forma.
Purtroppo all'inizio dell'autunno le condizioni di salute di Gramsci erano tali da creare in tutti noi molta preoccupazione. Continuava ogni giorno a scendere in cortile per il passeggio, ma parlava poco e si stancava presto. Era più nervoso del solito e si irritava facilmente coi compagni, specie se protestavano per cose di scarso valore sostanziale. Egli pensava, e lo affermò più volte nei momenti opportuni, che l'atteggiamento donchisciottesco di qualche compagno non era tollerabile perché era illogico e inconcludente. Insomma, non ammetteva che si fosse incapaci di capire che non si deve battere la testa contro i muri.
Rilevò anche che non sempre i rapporti tra i compagni erano corretti e leali ed appariva chiaramente che anche questi aspetti della vita carceraria erano per lui motivo di grande preoccupazione.
Venne l'inverno e le condizioni fisiche di Gramsci peggiorarono ulteriormente. Non riusciva più a dormire per notti di seguito e non sempre la causa dell'insonnia era da addebitarsi al suo stato di salute. La sua cella era situata proprio di fronte alla scala ove si svolgeva il traffico delle guardie e del personale di servizio, con gli inconvenienti che si possono immaginare dato che il continuo andare e venire durava tutta la notte. Il sospetto che un tale comportamento del personale di custodia facesse parte di un disegno per attentare alla vita di Gramsci era giustificato, anche se non era possibile dimostrarlo. Resta il fatto che le numerose, ripetute richieste perché gli ve-nisse data sistemazione in un'altra cella non furono mai accolte. La risposta era sempre la stessa: l'esigenza di una permanente vigilanza del detenuto non consente lo spostamento in un'altra cella.
Con l'arrivo della primavera del 1931 nelle condizioni di Gramsci si verificò un leggero miglioramento, tale da far pensare che la crisi più acuta della malattia fosse stata superata; ciò contribuì a dargli un po' di serenità e qualche momento di tregua nelle sue sofferenze. In aprile manifestò il desiderio di riprendere la conversazione con i compagni. Naturalmente noi lo incoraggiavamo, purché non ne derivassero pregiudizi per la sua salute. Riprese cosi la sua opera di educatore politico con l'impegno di sempre; ma era evidente che si sottoponeva a uno sforzo superiore alle sue possibilità fisiche. Tuttavia nessuno sarebbe riuscito a farlo recedere dal compito che si era assunto di aiutare i compagni a diventare più capaci, più agguerriti e più preparati per meglio assolvere i compiti a cui il partito li avrebbe chiamati quando sarebbero usciti dal carcere.
Quando lasciai la casa penale di Turi di Bari, nel luglio del 1931, insieme ad altri compagni come me trasferiti per sfollamento, ero convinto che Gramsci avesse ormai superato il periodo più grave della sua malattia. Ma, purtroppo, la mia era solo un'illusione, come gli avvenimenti successivi hanno dimostrato.
L'ordine di trasferimento mi venne notificato solo qualche ora prima della partenza, all'improvviso, per cui non potei neppure salutare i compagni coi quali avevo vissuto per sedici mesi. Passando davanti alla cella di Gramsci mi avvicinai allo sportello aperto della porta e lo salutai. Ero commosso e dispiaciuto di andarmene, di lasciare i compagni e soprattutto di perdere per sempre l'aiuto prezioso e la compagnia di Gramsci. Egli si rese certamente conto del mio stato d'animo e fece del suo meglio per consolarmi: "Stai allegro," mi disse, "ci rivedremo a Roma, quando faremo un concentramento di tutti i condannati dal tribunale speciale." "Spero di rivederti anche in Sardegna." risposi. E invece non ci siamo più rivisti.
Il fascismo lo ha fatto morire a poco a poco, secondo un preciso disegno realizzato con cura scientifica, attraverso lunghe persecuzioni. Ma pesanti limitazioni e grandi sofferenze allo scopo di umiliarlo moralmente e fisicamente non sono riuscite a fare di Antonio Gramsci un vinto. Il suo pensiero e le sue idee, anche quelle maturate e sviluppate dentro il carcere fascista, sono vive e potenti.
I suoi scritti e i suoi insegnamenti sono diventati strumenti preziosi in mano alla classe operaia e al suo partito, hanno formato centinaia di migliaia di comunisti, decine di migliaia di nuovi dirigenti, migliaia di intellettuali progressisti, milioni di combattenti per il progresso e il socialismo, in Italia e nel mondo. Evidentemente tutto ciò non era stato previsto dal gran capo fascista che lo aveva chiuso in carcere per impedire al suo cervello di funzionare.
SANDRO PERTINI
Sandro Pertini nacque a Stella (Savona) nel 1896. Medaglia d'oro al v.m., avvocato e giornalista. Attivo antifascista fin dal 1921, andò in esilio in Francia e rientrò in Italia nel 1929. Processato dal tribunale speciale scontò sette anni di carcere e poi il confino fino al luglio del 1943. Nello stesso anno fu arrestato dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre. Riuscì a evadere e partecipò alla Resistenza nell'Italia del Nord; fu tra i capi della lotta di liberazione e dell'insurrezione a Firenze il 25 aprile. Eletto alla Costituente e poi senatore di diritto. Direttore dell'" Avanti!" e poi de "Il lavoro" di Genova, membro della direzione e segretario del PSI. Presidente della Camera dei deputati fino al giugno 1976, fu eletto Presidente della Repubblica l’8 luglio 1978. Terminato il suo mandato nel 1985, proseguì l’attività parlamentare come senatore a vita, spegnendosi serenamente a Roma, amatissimo, il 24 febbraio 1990.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conobbi Gramsci nel carcere di Turi di Bari, dove, dopo qualche giorno dal mio arrivo, stringemmo subito amicizia. Gramsci dimostrò sempre verso di me un'amicizia leale, sincera e, per apprezzarne tutto il valore, deve essere messa in evidenza subito una cosa: in quei tempi, all'estero, socialisti e comunisti si sbranavano, esisteva tra loro una polemica aspra.
Io ho sempre disapprovato questa rottura perché sempre sono stato per l'unità del movimento operaio; quindi, l'amicizia concessami da Gramsci assunse per me un significato, oltre che sentimentale e umano, anche politico. Andavo sempre al passeggio con lui perché provavo un vero piacere ad ascoltarlo: la sua conversazione era sempre elevata, era un uomo di una cultura sempre di prima mano, preparatissimo; insomma, io avevo sempre da imparare standogli vicino.
Gramsci infatti è stato certamente il cervello politico più forte, l’uomo di più vasta cultura che io abbia conosciuto lungo il mio cammino di militante politico. Quando polemizzava, giungeva a toni molto forti, anche aspri; ma era molto più umano di quanto non sembrasse. Pensava sempre alla sua famiglia, ai suoi figli che erano lontani, in Russia, e me ne parlava con affetto.
Come descriverlo fisicamente? Ecco, occorre immaginare il corpo debole di un pigmeo e, su questo corpo, la testa di .un Danton. Aveva degli occhi color dell'acciaio che quando si fermavano sull'interlocutore non lo mollavano più: da essi sprizzavano tutta l'intelligenza e l'ingegno del suo cervello.
A Turi di Bari, oltre che con me, strinse amicizia con due ex anarchici che erano stati condannati dalla corte, d'assise di Milano; ma dopo un periodo di tempo di conversazioni con Gramsci, essi diventarono comunisti e gli furono sempre fedeli.
Queste amicizie gli venivano rimproverate dai compagni comunisti che erano nello stesso carcere. Si sa, infatti, che eccettuato qualcuno, ci fu un forte dissenso politico in quel periodo fra Gramsci e questo gruppo di comunisti. Gramsci se ne rammaricava con me: "Non hanno capito la mia posizione," diceva. Mi risulta che questo gruppo fece pervenire poi al centro estero del partito a Parigi Una relazione sulle posizioni politiche di Gramsci, quasi denunciandolo come un deviazionista; la stessa sorte del resto capitò a Terracini e alla Ravera che al confino erano considerati fuori dal partito. Gramsci soffriva molto di quella situazione. Era malato; stava solo in una cella ed era stato autorizzato a tenere penna e calamaio: gli strumenti che gli consentirono di scrivere i Quaderni del carcere. Anche per questo gli venivano mossi dei rimproveri, non dai comunisti, ma da parte dei detenuti anarchici : "È un privilegiato," dicevano, "lui ha la penna e noi non la possiamo avere."
Ma, ripeto, la sua grande amarezza derivava dall'ostilità che gli dimostrava il gruppo dei detenuti comunisti che era a Turi, fatta qualche eccezione. È inutile che faccia il nome di questi compagni; ricordo però che, a un certo punto, anch'io cercai di intervenire per sanare questo dissidio; ma non fu possibile approdare a risultati. Dissi fraternamente ai compagni comunisti: "Fate male a lasciarlo solo." Perché non era lui che teneva a distanza i compagni, ma erano loro che l'avevano isolato. Perciò lui continuava a stare con me e con i due ex anarchici milanesi.
Era gravemente ammalato e soffriva d'insonnia: dormiva poche ore per notte o alle volte aveva notti completamente insonni. Quando riusciva ad addormentarsi bastava il minimo rumore per svegliarlo. Una volta si sfogò con me. Mi disse: "Tu sai che le guardie, durante la notte vengono due volte a sorvegliare; quando aprono lo sportello della mia cella per l'ispezione lo richiudono sempre sbattendolo forte; io mi sveglio, e poi non riprendo più il sonno; e, purtroppo questo accade molto spesso." Era una situazione intollerabile e, a sua insaputa, io decisi di chiedere udienza al direttore: "Mi risulta," gli dissi, "che le guardie quando vanno alla notte a fare ispezione nella cella di Gramsci aprono lo sportello e, invece di richiuderlo senza far rumore, lo sbattono appositamente per svegliarlo. E Gramsci non riesce più a prender sonno. Lei deve intervenire per far cessare questo stato di cose; altrimenti io farò un rapporto al ministero della giustizia e degli interni." Il direttore mi rispose: "Farò un'indagine."
Qualche giorno dopo incontrai Gramsci al passeggio molto più sereno: "Sai?" mi disse, "va molto meglio. Le guardie hanno appreso a richiudere lo sportello della cella con una certa delicatezza. Non lo sbattono più come prima e io riesco a riposare meglio." Quindi il mio intervento aveva avuto un esito positivo; me ne rallegrai, anche se non gli dissi mai che ero intervenuto in suo favore.
Un altro giorno Gramsci mi disse: "Noi due dobbiamo iniziare una conversazione che durerà due mesi." "Che duri due mesi, due giorni o un anno è lo stesso," risposi, "perché qui, ormai, l'orologio per noi si è fermato. D'altra parte conversare con te è sempre di grande interesse, perché ascoltandoti imparo sempre qualche cosa."
Capii subito dalle sue prime battute che voleva persuadermi a passare al Partito comunista; non riusciva a comprendere che un uomo come me, con la visione che avevo della lotta, col mio temperamento, potesse rimanere coi socialisti. Ma quando gli dissi: "Non posso lasciare il mio partito, cui sono devoto. Posso anche dissentire da certi atteggiamenti, ma ci rimango," lui rispettò questa mia posizione.
Allora, per i comunisti, noi socialisti eravamo dei "so-cialfascisti." Non per Gramsci, poiché egli prevedeva che un giorno vi sarebbe stata un'alleanza tra i socialisti, i comunisti e tutte le forze antifasciste. E riteneva fosse un grave errore quello di certi suoi compagni che ancora persistevano su questa posizione nei nostri confronti. A Turi di Bari io ero l'unico socialista, tra i detenuti; ecco perché Gramsci, cosi sensibile umanamente, dimostrò questa attenzione verso di me. Io ero solo, mentre erano molti i comunisti: Riboldi, Lo Sardo, Lisa, Lai, Tosin, Tulli e Angelo Scucchia, romano. Fu questa realtà che indusse Gramsci ad avvicinarsi a me, perché non rimanessi isolato, dato il contrasto che esisteva allora negli ambienti dell'emigrazione fra socialisti e comunisti.
Gramsci parlava con grande ammirazione dei suoi compagni che si prodigavano all'interno dell'Italia nell'organizzazione clandestina. Ma pensava che non bisognava illudersi di fare un'organizzazione efficiente tanto da poter influire sulla caduta del fascismo.
Era assistito molto fraternamente dalla cognata che credo lavorasse a Roma presso l'ambasciata sovietica. Gli faceva avere medicinali e generi alimentari. Cosi, alla vigilia di Pasqua, mi pare del 1931, ricevette un grande pacco di viveri e, in cortile, mi disse: "Sai, ho chiesto al direttore che tu possa venire nella mia cella. Ho già preparato tutto. 3È Pasqua, e consumeremo insieme il pranzo che mi ha mandato mia cognata." Ma il direttore si comportò proprio male: gli lasciò intendere che mi avrebbe concesso di andare nella sua cella, ma, all'ultimo momento, revocò la concessione. Ricordo che anch'io aspettai a lungo che mi aprissero il cancello per andare giù da Gramsci.
Perciò non se ne fece nulla, e ci trovammo in cortile come al solito. Gramsci era molto rattristato : "Non ho mangiato nulla," mi disse. "Ero troppo irritato. Ho dato tutto agli scopini."
Durante la mia permanenza a Turi accadde anche quell'increscioso episodio del sasso lanciato contro Gramsci. E a questo proposito voglio precisare subito una cosa : non è vero che siano stati i comunisti a lanciarlo. La verità è questa: ci fu una nevicata e i detenuti durante il | passéggio tiravano palle di neve. Un gruppo prese di mira * Gramsci che si rifugiò in un angolo per evitare di essere colpito dai loro tiri. A un certo punto una palla si infranse sul muro, al quale Gramsci si appoggiava, e ne usci fuori un sasso. Io gli ero accanto e l'udii dire: "Avevano messo un sasso nella palla di neve per colpire me." Qualcuno più tardi ha affermato che autori del disgustoso gesto furono i comunisti. Io affermo che non è vero. Fu un altro gruppo di detenuti ed ormai è inutile dire quale fosse la loro qualità politica.
Gramsci era legatissimo alla Sardegna. Mi raccontò della sua giovinezza e dì come avesse potuto studiare solo grazie a delle borse di studio. Ma soprattutto parlava con molta amarezza della condizione umana del contadino sardo. Aveva una grande ammirazione per Emilio Lussu, al quale era legato da vera amicizia, e ricordo che mi diceva: "In fondo, Emilio Lussu è un socialista." (Lussu diventò socialista in seguito, ma allora militava nel Partito sardo d'azione.) Cosi anche aveva grande ammirazione per i meridionalisti, per Giustino Fortunato, ad esempio, e si interessava molto del problema meridionale.
Ma soprattutto, ricordando le conversazioni con Gramsci, mi tornano alla mente i suoi discorsi su Torino operaia. Mi raccontava che, alla sera, dopo aver lavorato al giornale, era felice di poter prendere contatto con gli operai della Fiat. Diceva: "Poter stare con gli operai era un grande conforto per me, come un bagno di umanità. E quante esperienze ho tratto da quegli incontri! Sai, gli uomini di cultura devono essere come delle levatrici, cioè devono estrarre loro dalla mente dell'operaio, dal movimento operaio, tutto ciò che serve per la lotta, per la loro stessa cultura." E aggiungeva: "Guai a quegli intellettuali, anche d'avanguardia, che si chiudono nella torre d'avorio della loro cultura e credono che questo basti per esprimere il loro pensiero, senza stabilire legami con la classe operaia. L'intellettuale, se vuole provare la validità del suo pensiero e delle sue concezioni, deve stare a contatto col movimento operaio; chi se ne distacca gira a vuoto." E ricordo anche uno degli avvenimenti del suo periodo torinese che mi raccontò a questo proposito: To-scanini andò in quegli anni a Torino per tenere dei concerti sinfonici al Teatro Regio e un gruppo di operai si recò da Gramsci e gli disse: "Noi vorremmo andare a sentire Toscanini." Gramsci si fece subito interprete di questo desiderio degli operai, ma alcuni di coloro che interpellò, sorrisero scettici. Avvicinò, mi pare, anche alcuni dirigenti della stessa Fiat. Poi, finalmente, ottenne che fosse dato un concerto al Regio solo per i lavoratori. "Ebbene," mi raccontava a Turi, "dopo il concerto, che non era di musiche leggere, ma comprendeva la Quinta sinfonia di Beethoven e altro, Toscanini fece questa dichiarazione: 'Ho avuto altre soddisfazioni di fronte ad altre platee, ma la più grande è stata quella provata qui, di fronte a questo pubblico di operai, che ha capito veramente, ha sentito la musica da me diretta.'"
Gramsci era molto ammalato e il lungo soggiorno in carcere aggravò le sue condizioni di salute. Indubbiamente in libertà sarebbe riuscito a sopravvivere. Il pubblico ministero al tribunale speciale disse che per vent'anni quel cervello non avrebbe più dovuto funzionare e il fascismo lo fece tacere per sempre. È falso dire che Gramsci sarebbe morto ugualmente anche se fosse stato fuori, in libertà. Fuori avrebbe potuto essere curato. Il carcere logora anche fisici sani, e stronca quelli deboli com'era il suo. Se fosse stato in Russia, come Togliatti, sarebbe stato curato e sarebbe vissuto. Non vi è dubbio, su questo.
Io, quando appresi della morte di Gramsci, piansi. Come piansi quando mi annunciarono che era morto Filippo Turati. Dal punto di vista affettivo, la morte di Gramsci è stata per me la perdita di un amico carissimo. Ma capii anche che si trattava di una grave perdita politica, non solo per il Partito comunista, ma per tutto il movimento operaio italiano e internazionale. Questa morte ha lasciato un vuoto profondo, che non è stato colmato da nessuno.
Sono convinto che anche Mussolini abbia sempre avuto una grande ammirazione per l'ingegno di Gramsci. Del resto quel che accadde alla Camera dei deputati nella seduta del 16 maggio 19251 sta a dimostrarlo. Quel giorno, mentre Gramsci parlava, fu interrotto da un fascista, Ferrétti, che gli lanciò l'ignobile insulto: "Taci, Rigoletto!" Mussolini chiamò il deputato fascista, lo rimproverò acerbamente e gli ordinò di andare a chiedere scusa. Quando vide salire verso il suo banco questo fascista Gramsci disse: "Io non accetto nessuna scusa, non la voglio neppure ascoltare. Avevo da dire cose troppo interessanti per poter sentire le sue interruzioni!" E lo mandò via.
1 Fu l'unico discorso pronunciato da Gramsci alla Camera dei deputati contro il disegno di legge Mussolini-Rocco rivolto contro la Massoneria, ma indirettamente contro i partiti antifascisti.
ANGELO SCUCCHIA
Angelo Scucchia nel 1926 entrò a far parte del Partito comunista e contribuì alla nascita dei comitati di fronte unico e alla ricostituzione delle cellule e dei nuclei sindacali. Nel 1927 visse una breve parentesi a La Spezia dove venne assunto dalle imprese Devoto e organizzò una lotta di oltre 500 edili e delle loro famiglie fino a una manifestazione di protesta davanti ai sindacati fascisti e in piazza del Tribunale. Nell'estate del 1927 rientrò a Roma e dalla federazione del partito fu incaricato della riorganizzazione e della propaganda nel settore Esquilino-Tiburtino.
Subì il primo arresto per la sua attività politica nello stabilimento Manzolini, poi nel novembre dello stesso anno venne arrestato per la seconda volta e condannato dal tribunale speciale a 6 anni e 3 mesi di reclusione. A Turi di Bari conobbe Gramsci e con Lisa ed altri partecipò alla polemica sulla "svolta." Nel 1932 ritornò a Roma e riprese l'attività clandestina. Nel 1934 venne inviato al confino a Ponza. Usci dal Partito comunista nella primavera del 1934. Dopo la Liberazione si iscrisse al PSI.
Sul suo ruolo negativo nei confronti di Gramsci, così lo ricorda Cesare Bermani:
<Poi da Turi mi hanno trasferito a Bari, dove era stato trasferito in precedenza anche Angelo Scucchia. Di lui m'aveva parlato Garuglieri e m'aveva detto che era uno dei più accaniti contro Gramsci. Infatti anche a Bari questo qua continuava a dire male di Gramsci, che era un privilegiato, che era un egoista, proprio anche a demolire la personalità sua. Allora io, sentendo queste cose, e sentendo anche quello che dicevano gli altri detenuti, ho avuto con lui un contrasto molto eccitato e l'ho anche smascherato, dicendo che lui era uno dei provocatori. E l'avevo anche accusato di provocazione. Sai, gli altri sono rimasti sorpresi, ma nel fondo c'era anche da parte loro l'ammirazione per Gramsci, che era il capo del partito, che era in carcere e quindi... Così Scucchia ha smesso di andare da uno e dall'altro a parlare contro Gramsci, non ne ha più parlato>.
[in Cesare Bermani, Gramsci in carcere a Turi nel 1932, conversazione con Aldo Magnani in "l'impegno", a. XI, n. 3, dicembre 1991.
Aldo
Magnani scrisse in Sessant'anni di un militante comunista reggiano,
Milano, Teti, 1982, pag.92: "Scucchia da quando era a Bari svolgeva
un'azione denigratoria contro Gramsci fino a spacciare per vero un suo presunto
distacco dal partito, e dando una versione sostanzialmente calunniosa dei
rapporti fra Gramsci e i compagni, ben diversa dalla descrizione che ne fa nella
testimonianza pubblicata nel volume 'Gramsci vivo', dove del resto ammette le
provocazioni usate contro Gramsci. Nel cortiletto del carcere ebbi un violento
scontro ove dimostrai i suoi fini provocatori, dopo di che anche gli altri
detenuti politici ruppero i contatti con lui".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ho conosciuto Antonio Gramsci alla casa penale cosiddetta di cura di Turi di Bari nel 1930.
Mi ero trovato precedentemente al reclusorio di Padova dove, a seguito di susseguenti segregazioni, digiuni, isolamenti e punizioni disciplinari, mi ero procurato una gastroenterite che da acuta diventò cronica. A Padova, dopo alcuni mesi trascorsi negli stanzoni del penale con altri comunisti e anarcosindacalisti, fui ricoverato alla infermeria del carcere. Ma poiché le mie condizioni di salute non miglioravano assolutamente, il medico che la dirigeva (un massone che mi aveva preso a benvolere) avanzò l'idea di una casa penale di cura.
Scartata la prospettiva di Pianosa, dove mi sarei preso certamente la tbc, mi prospettò due possibilità: Turi di Bari e Paliano. Paliano si trova vicino a Roma e quindi mi avrebbe offerto la possibilità di vedere sovente mia madre, ma non intendevo andarci perché sapevo che vi erano raccolti tutti i vecchi e i cronici; invece l'idea di Turi mi attirava perché vi era recluso Antonio Gramsci. Perciò pregai il medico di fare il possibile per farmi assegnare a Turi. Un giorno, infatti, mi chiamarono, mi dissero di prendere tutta la mia roba e, quando fui nella cella di transito, mi comunicarono che sarei partito per Turi.
Avevo conosciuto Antonio Gramsci soltanto attraverso la vita di partito e i discorsi dei compagni o qualche residuo di giornale che mi era pervenuto nella clandestinità a Roma; ma personalmente non l'avevo mai visto. Quindi lascio immaginare con quanta ansia e con quanta fretta mi accingessi ad intraprendere questo interminabile viaggio di traduzione con le fermate nei transiti più immondi, specialmente quello di Foggia,
In attesa di proseguire il viaggio mi fermarono per qualche giorno al carcere giudiziario di Bari. Nella mia cella erano tutti detenuti comuni, di politici c'ero soltanto io e una specie di anarchico che era pure diretto a Turi. Al mattino entrò un capoguardia e al suo ingresso tutti scattarono in piedi e fecero il saluto romano. Poiché io non l'avevo fatto-, mi apostrofò con arroganza. Gli risposi tranquillamente: "Il regolamento non prevede il saluto romano; e poi io sono un detenuto politico, sono un comunista."
Non feci in tempo a finire questa frase che mi presero, mi scaraventarono in una cella buia di punizione, mi avvolsero in una coperta e mi picchiarono selvaggiamente; alla fine avevo tutto il corpo dolorante e coperto di ecchimosi. Chiesi di essere chiamato a rapporto dal direttore del carcere e dal medico. Dopo tre giorni ottenni di essere visitato, ma naturalmente non avevo niente di rotto e perciò il medico mi disse che non poteva segnalare il mio caso. "Adesso se ne andrà a Turi di Bari," aggiunse, "e là potrà essere curato; qualche sconsiderato capita, non se la prenda!"
Il confronto col direttore del carcere non diede migliori risultati; era un gerarca e mi ricevette vestito in divisa. Non mi lasciai intimidire; chiesi formalmente che fosse aperta un'inchiesta. "Oggi è capitato a me, ma potrebbe succedere anche ad altri miei compagni nel futuro," mi dicevo. Lui cercò di tergiversare, poi dovette stendere la dichiarazione che firmai.
Pochi giorni dopo il mio viaggio di trasferimento si concluse e arrivai a Turi; trascorsi come tutti i nuovi arrivati alcuni giorni in segregazione, poi fui assegnato alla cella dove già si trovavano Giovanni Lai e Spadoni. All'ora del passeggio incontrai Gramsci.
Come faceva con tutti i compagni nuovi arrivati, Gramsci mi prese da parte e s'informò dei miei precedenti politici, delle mie esperienze nell'attività di partito; volle sapere come stavano i compagni nel reclusorio di Padova, quali notizie avevo raccolto durante il transito. Durante i transiti, infatti, si aveva occasione di incontrare spesso i compagni che si spostavano per andare al tribunale speciale o quelli che venivano assegnati definitivamente alle case di pena e si aveva la possibilità di avere da loro notizie più o meno fresche.
Ma in quel periodo nel partito non esistevano questioni drammatiche di rilievo; c'era un grosso impegno di tutti i compagni sia in Italia che all'estero per mantenere l'ossatura della nostra organizzazione e per dare vita a quelle poche manifestazioni politiche o sindacali che erano ancora possibili.
Dopo quel nostro primo incontro io ero impaziente di sentire Gramsci nel vivo della trattazione di problemi ideologici e politici, ma i compagni di cella mi confortarono dicendo: " Vedrai che nei prossimi giorni, durante il passeggio, verrà da sé che Gramsci affronti questo tipo di conversazione, spontaneamente o sollecitato da nostre domande."
Cosi iniziò il mio nuovo periodo di vita carceraria.
La vita di cella, a tre, era abbastanza normale e monotona. Si leggeva, si discuteva e si aspettava con molta ansia l'ora del passeggio. All'aria ebbi modo di conoscere anche molti altri compagni che stavano in altre celle e il grosso del nostro gruppo di comunisti che invece era nel camerone dell'infermeria del carcere. Infatti in questo camerone dell'infermeria c'erano circa quindici o venti condannati politici tra i quali cominciavano a prevalere come numero i comunisti; ma c'erano anche anarchici, quelli della Lunigiana, per esempio, e alcuni goriziani e slavi.
Gramsci allora era isolato nella cella al primo piano e vicino alla sua c'era la cella dove, pure isolato, stava Lo Sardo.
Tra i detenuti c'erano molti ammalati e con una vasta gamma di malattie: dalla tbc alle gastroenteriti, arteriosclerosi, uricemie, ecc. Questo però non limitava affatto il nostro interesse per i problemi politici e culturali e per la lettura. Antonio, naturalmente, era il più fornito di libri e ce li prestava; anche noi riuscimmo a procurarne un certo quantitativo attraverso la casa editrice Laterza che ci forni addirittura pubblicazioni di Lenin, Marx, Engels, Bucharin, Plechànov stampate dalle Editions sociales internationales. Giornali quotidiani non ne arrivavano, ma avevamo a disposizione riviste e periodici; quelle di carattere letterario, politico ed economico che pervenivano a Gramsci e in misura più ridotta a Tulli, a Lo Sardo e a Lisa.
Anche qualcuno di noi che aveva disponibilità economiche ordinava, attraverso la famiglia, alcune riviste; naturalmente quelle consentite dalla censura interna: giornali cattolici, periodici come "Vita e pensiero," "Critica fascista," "Gerarchia." A Gramsci arrivava regolarmente "Politica" di Coppola che era importante per tutti noi poiché dai suoi articoli riuscimmo ad avere notizie preziose sull'Unione Sovietica, sulla Nep, sulle lotte interne nel Partito comunista bolscevico, sui contrasti tra città e campagna, i kulak ecc. Quindi eravamo abbastanza informati; ma ci mancavano notizie dirette e continue sulla vita di partito.
E, nonostante il bisogno di conoscenza su questi problemi fosse vivissimo in tutti noi, dovevamo accontentarci di ciò che si veniva a sapere durante i transiti o nei rari casi di qualche colloquio con i familiari. Ma, per la maggioranza di noi, forse con la sola eccezione di Gramsci, i colloqui non avevano nessun diretto riferimento con la vita di partito. Quindi andavamo un po' per intuizioni.
Per quanto riguarda invece la vita internazionale a Gramsci arrivavano due riviste molto interessanti pubblicate dal Minculpop e a cura del ministero degli esteri. Erano la "Rassegna quindicinale" e la "Rivista settimanale della stampa estera" in cui venivano riportati citazioni e riassunti di articoli de "l'Humanité," de "Le populaire," della "Pravda," delle "Izvestija" e di molte altre riviste inglesi ed americane. Questi testi, letti criticamente, riuscivano a darci un quadro abbastanza completo di ciò che avveniva nel mondo.
Dentro il carcere, come ho detto, potevamo leggere un certo numero di libri, ma la cosa fondamentale per tutti noi era la presenza di Gramsci.
In quel periodo — parlo sempre del 1930 — egli aveva già portato avanti il suo lavoro di stesura di appunti, di elaborazione di materiale e di idee che porteranno poi al grande risultato dei Quaderni, ma nei suoi colloqui con noi non aveva ancora puntualizzato tutta la tematica della sua opera, anche se ogni tanto ci preannunciava degli argomenti: per esempio gli intellettuali, il Machiavelli, i rapporti tra cultura marxista, storia e storiografia del nostro paese. Queste discussioni con lui avvenivano mentre si passeggiava nel cortile: dopo aver giocato alcune partite a dama — che Gramsci ormai vinceva sistematicamente perché era diventato bravissimo e non perché noi per piaggeria lo lasciassimo vincere — quando era stanco di stare seduto sul muricciolo a giocare e a fumare (fumava molto, accanitamente, sigarette fatte a mano con una mistura di menta e di macedonia), iniziava a passeggiare.
Noi ci disponevamo al suo fianco, qualcuno lo precedeva, altri lo seguivano. Ma non era un cerimoniale come certi hanno lasciato intendere, non era una specie di rito. Chiedevamo chiarificazioni, ponevamo domande. Ma non si trattava di lezioni accademiche, niente di professionale o pedante. Si affrontava un argomento, qualche volta lo si interrompeva per riprenderlo il giorno dopo e nei giorni seguenti.
Certo, senza voler fare della piaggeria inutile, gli interventi di Antonio erano sempre di un estremo interesse; perché non era un erudito, era un grande intellettuale che sapeva rielaborare criticamente temi, fatti e personaggi e sapeva proporli in modo nuovo. Per cui gli stessi temi, gli stessi argomenti, ritrovati poi in un libro di storia o di filosofia, apparivano tutta roba trita e barbosa a confronto con l'esposizione che ne avevamo sentito fare da Gramsci. Era vivacissimo e aveva la grande qualità di non mettere in soggezione i compagni, di non far sentire il distacco fra lui che ne sapeva tanto e la maggioranza di noi che ne sapeva molto poco. Si metteva subito alla pari coi suoi interlocutori.
Dal punto di vista della salute aveva degli alti e bassi; un giorno era di umore allegrissimo, spiritoso, altri giorni era più burbero, più concentrato. Noi cercavamo di infastidirlo il meno possibile con domande sulla sua salute, anche se gli stavamo intorno in modo affettuoso. In quel periodo soffriva di frequenti cefalee e lo tormentavano soprattutto i denti che andava perdendo per la piorrea. Capivamo i suoi silenzi e cercavamo di parlare d'altro, di distrarci anche con argomenti futili. Ma non ricordo in. quel periodo allarmi particolari per la sua salute.
Certo, l'assistenza medica nel carcere era pressoché inesistente; il medico se la cavava con la prescrizione di qualche polvere, qualche rara iniezione a seconda delle malattie che avevamo. Il vitto, che rispetto ai reclusori comuni avrebbe dovuto essere privilegiato, si riduceva a qualche verdura cotta (noi la chiamavamo pasta e stracci), qualche pastasciutta, qualche uovo sodo; ma niente di qualità, niente di speciale. Tutta roba che a molti di noi faceva più male che bene.
C'era un ambulatorio dove ci alternavamo noi e i reclusi comuni, ma per interventi di normalissima amministrazione come estrazioni di denti o simili; niente insomma che legittimasse il titolo di "casa penale di cura" al penitenziario di Turi di Bari. E soprattutto per quanto riguardava Gramsci e anche Lo Sardo, che era molto ammalato, questo trattamento non era certo tale, non dico da garantire una guarigione, ma neppure la stabilizzazione delle loro condizioni di salute.
C'erano una sorveglianza e una censura abbastanza rigide. Ogni tanto dovevamo reclamare per i libri che ci venivano trattenuti perché non consentiti; ma spesse volte questa censura, come tutte, finiva per essere anche cretina. Fermavano infatti dei libri insignificanti perché avevano dei titoli che davano nell'occhio e ne lasciavano passare altri, come ad esempio quelli che ho citato editi da Laterza.
Tutti eravamo molto disturbati dal passaggio notturno dei secondini che battevano ai ferri delle celle; ma nel periodo che io vi trascorsi non si verificarono punizioni corporali con bastonature ai detenuti. Penso che la presenza di Antonio, e anche di Riboldi e Lo Sardo che erano ex deputati, avrebbe potuto in casi del genere suscitare reclami dall'esterno. E, come tutti sanno, il regime ci teneva molto, soprattutto di fronte all'opinione pubblica estera, a far passare il trattamento riservato ai prigionieri politici come normale.
Questa era, a grandi linee, la nostra vita nel penitenziario di Turi. Alcuni di noi provenivano da altre carceri dove avevano avviato in modo quasi organico delle vere e proprie scuole di partito e sentivamo tutti che con la presenza di Gramsci e anche di alcuni altri ci sarebbe stata l'occasione di organizzare meglio che altrove una attività di questo tipo. Per esempio, ci sarebbe piaciuto che Gramsci iniziasse una serie di conversazioni sui rapporti tra il partito e il movimento operaio, e sui compiti del partito in quel periodo, anche perché quelli tra noi che avrebbero goduto dell'amnistia o del condono, che si profilava per il 1932, uscissero dal carcere meglio preparati per riprendere l'attività esterna.
Delegammo Lisa, che era il più qualificato, a porre a Gramsci la richiesta per questa serie di conferenze. Lisa era il solo tra noi con la qualifica di funzionario, e anche il più aggiornato sulla linea del partito; e riuscì a convincere Antonio. Le conversazioni non dovevano avere un fine intellettualistico o culturale fine a se stesso, ma quello di migliorare la nostra preparazione. Devo dire infatti che tra i compagni detenuti a Turi, a differenza di altri posti, quasi nessuno prevedeva — una volta riottenuta la libertà—di riparare "all'estero o di andare in Unione sovietica a curare le proprie malattie; in quasi tutti noi c'era l'ansia di uscire per riprendere la lotta, il nostro posto nelle file del partito.
Non sono in grado adesso di elencare ordinatamente i temi trattati, comunque Gramsci iniziò a parlarci della concezione marxista della classe "in sé" e "per sé." Riteneva infatti fondamentale e pregiudiziale sviscerare questi concetti della classe operaia che da "classe in sé" si evolve a "classe per sé" cioè a classe che acquista coscienza della propria funzione storica, lotta politicamente ed esprime il partito.
Quando io penso alla concezione del partito della classe operaia non posso non pensare a Lenin, ma soprattutto non posso non pensare a Gramsci.. Il partito era l'idea centrale di tutta la sua concezione, di tutta la sua impostazione politica. Quindi se qualche intellettuale, ancora oggi, vuole restringere il pensiero di Gramsci in schemi estetici o letterari o filosofici non intende che la sua cultura, il suo approfondimento, la sua concezione del partito come "principe," come forza egemonica, non è intellettualistica ma sbocca sempre nella prassi, nell'azione. Per Gramsci il partito era il collettivo rivoluzionario, la formazione di base, il futuro Stato dell'avvenire socialista e comunista. Era una anticipazione di avvenire, senza cadere nell'utopismo, nell'avventurismo o nel profetismo.
Io, Lisa e altri, però, trovavamo se non lacunosa ancora insufficiente questa analisi sulla natura e i compiti del partito e chiedemmo ad Antonio che facesse anche una trattazione preliminare della situazione internazionale e nazionale dal punto di vista economico. Lui, con tono scherzoso, ci rispose: "Io sono un cultore di economia, non sono un economista. Perciò le notizie di carattere economico prendetele dalle riviste e dai dati che abbiamo a disposizione." Quindi cominciò a trattare l'argomento Stato-regime: i rapporti tra il regime fascista, la Chiesa, la monarchia, le classi dominanti borghesi, i ceti intermedi. Tutta una grossa tematica, dunque, dalla quale scaturiva che, con le deficienze di presenza e di funzionamento del nostro partito nel paese, per quanto trapelassero notizie di scioperi e di manifestazioni di malcontento per le condizioni economiche, la via d'uscita non poteva essere quella rivoluzionaria.
Gramsci diceva: "C'è una corrosione all'interno della borghesia, in senso antifascista, anche se non attiva, non organizzata. Altrettanto avviene negli ambienti monarchici, negli alti gradi dell'esercito, tra i rappresentanti dei Savoia e d'Aosta, gelosi delle ascese delle nuove leve della milizia in contrapposizione a quelle dell'esercito tradizionale; la vecchia burocrazia si vede anch'essa tallonata e minacciata dai nuovi gerarchi fascisti." Poi parlò a lungo degli intellettuali, tra i quali prevedeva pure una crescita antifascista partendo dai fermenti che si potevano cogliere anche attraverso gli articoli di "Gerarchia" e di "Critica fascista." Ma, dato questo quadro, egli scartava le ipotesi estreme, cioè la soluzione rivoluzionaria e la prossima disfatta del fascismo attraverso la guerra. Non voglio dire che Gramsci non vedesse nel fascismo un foriero di guerra, né che scartasse all'orizzonte più o meno remoto il pericolo di un conflitto, ma non lo vedeva come una ipotesi vicina.
Gramsci insisteva invece sulla fase intermedia, cioè un periodo di libertà borghesi in cui come partito della classe operaia dovevamo svolgere subito un ruolo, inserendoci attivamente. E questa era l'indicazione che ci dava per il nostro lavoro nei partito e tra le masse che avremmo dovuto svolgere uscendo dal carcere: preparare le condizioni per la fase intermedia.
Noi però non vedevamo questa possibilità e ribadivamo: "Siamo stati l'unica forza politica che, seppure momentaneamente battuta, ha dato e continua a dare al paese, quindi non possiamo prestarci, né farci portatori della parola d'ordine della Costituente. Vogliamo saltare questa tappa e approfondire tra le masse la linea rivoluzionaria già indicata dal partito per giungere alla dittatura del proletariato, col fronte unico dal basso, facendo leva sull'acuirsi dei contrasti sociali e sulla radicalizzazione della lotta e non sull'antifascismo borghese o dando credito alle fratture tra classi dominanti e fascismo"; non vedevamo insomma come da tutto questo coacervo di fermenti, di opposizioni, di speranze deluse della borghesia e degli intellettuali borghesi potesse scaturire qualche cosa.
Eravamo tutti all'oscuro della presvolta e tanto più della "svolta" sulla quale si stava spostando allora l'orientamento del centro del partito. Ci guidava soltanto la nostra ansia di cambiamento, di rivoluzione, di salto dal fascismo alla dittatura proletaria.
Devo precisare che tra noi non c'erano né bordighiani, né trotskisti; niente di tutto questo;, non è neanche vero che vedessimo la rivoluzione alle porte del carcere. Sapevamo che per realizzarla erano necessarie condizioni favorevoli sia oggettive che soggettive che occorreva determinare con l'organizzazione del partito e la mobilitazione delle masse. Ma non eravamo d'accordo di scartare l'ipotesi del salto rivoluzionario per abbattere il fascismo.
Lisa, io e alcuni altri eravamo su posizioni anche più avanzate di quelle delle Tesi di Lione, cioè: come finalità dittatura proletaria e come mezzo preparazione del partito a svolgere un ruolo trainante sulle altre formazioni politiche antifasciste. Quindi preparare quadri nuovi, selezionati — e il carcere come università rivoluzionaria ci avrebbe aiutato —, ricostruire il partito per sfruttare i contrasti interni, esistenti nella società italiana e acuitisi durante la crisi del 1929-30, per realizzare il salto rivoluzionario. Niente parola d'ordine della Costituente, quindi, che non poteva distinguerci dagli altri.
La tesi della Costituente in funzione antifascista e repubblicana non aveva nulla a che vedere con la Costituente che si è realizzata dopo la guerra di liberazione; la Costituente che allora propugnava Gramsci doveva dimostrare nella fase intermedia che i partiti antifascisti che non fossero il Partito comunista non potevano a lungo o a breve termine offrire nessuna soluzione ai problemi economici e sociali che agitavano il paese e che erano diventati per molti aspetti una piaga cronica nel tessuto nazionale.
La Costituente doveva darci un lasso di tempo tale da poter lavorare tra le masse per dilatare la presenza del partito e passare poi a fasi più avanzate. Solo dopo questo
periodo, secondo Gramsci, sarebbe stato possibile, anche per l'acutizzarsi dei rapporti interni economici e politici, superare la fase democratico-borghese.
Questi erano gli argomenti più scottanti del nostro dibattito, ma devo dire che durante le conversazioni non avvenne assolutamente niente di drammatico/perché di fronte alle nostre obiezioni Antonio non si infastidiva affatto, non aveva mai l'atteggiamento di chi è convinto di essere il depositario della verità. Certo, cercava di argomentare per portarci sulla sua linea, anche perché quando aveva maturato una opinione non era il tipo da farsi smontare dalla prima obiezione. Ma non c'era in lui nessuna impuntatura, nessun senso di fastidio nei nostri confronti. A un certo punto ci disse: "Ciò che ho esposto, tenendo conto delle vostre domande e delle vostre risposte, è bene che sia da voi meditato e discusso. Tra qualche giorno ci ritroveremo per trarre le conclusioni." E sollecitò da noi una presa di posizione che fosse anche un impegno a sostenere la sua tesi quando saremmo tornati alla nostra vita di militanti all'esterno.
Giovanni Lai, che io ricordo sempre con affetto fraterno, parla di ciò che a questo punto avvenne nelle varie celle. Egli dimentica però che il grosso del dibattito non si svolse nelle celle, dove eravamo in pochissimi e che erano molto poche, ma soprattutto nel camerone. Certo, anche nelle celle i commenti erano più o meno accesi; gli aggettivi si sprecavano ed erano quelli di moda allora: filofascisti, crociani, opportunisti, traditori. Ma non si pensava a nessun duello rusticano sulle nostre vedute e i nostri disaccordi. C'era abbastanza vivacità anche tra i costituentisti.
Io mi trovavo nel camerone con Lisa, Tulli, Riboldi, Masiero, tre o quattro anarchici, Usai, Ceresa, Piacentini e Pertini, che però non partecipava alle nostre discussioni. Ricordo che la parola che ricorreva più di frequente nelle nostre valutazioni era "opportunismo." Ma certamente non volevamo intendere opportunismo personale di Gramsci o di altri, volevamo dire opportunismo politico. Certo si diceva "posizione antipartito," ma non era un'accusa, era una battuta per vivacizzare la discussione, cosi come lo erano le affermazioni di "deviazionismo," "tradimento ideologico," ecc. che pure ricorrevano nei nostri discorsi. Ma dietro questi aggettivi eccessivi, queste sfuriate, questo bollarci reciprocamente, questo azzannarci a vicenda c'era la passione politica. Il Partito comunista non era fatto di angioletti, ma di combattenti; più o meno raziocinanti o razionali, se vogliamo.
Si giunse cosi alla vigilia del nostro incontro decisivo con Gramsci. L'indomani ci saremmo ritrovati nel cortile, Lisa avrebbe dovuto svolgere la relazione a nome del gruppo anticostituentista, ma anche noi ci eravamo preparati ad intervenire per puntualizzare alcune questioni. Sennonché tutto precipitò la mattina seguente mentre scendevamo le scale per portarci all'aria.
Dal camerone, che era al secondo piano, dovevamo passare davanti alla cella di Antonio e in genere ci fermavamo ad aspettarlo. Quel giorno fummo preceduti da Ceresa e Piacentini, i quali si affrettarono ad affiancarsi a Gramsci e gli dissero qualcosa sottovoce. Non so se fecero questo per eccesso di zelo o perché si erano scandalizzati nell'apprendere della relazione di Lisa, delle controrelazioni mie e degli altri, delle aggettivazioni pesanti che si erano usate nel camerone durante il dibattito preparatorio.
Con Ceresa e Piacentini Gramsci si staccò dal gruppo e noi ci guardammo l'un l'altro chiedendoci cosa mai fosse successo. Giunti in cortile, appena varcata la porta metallica, come tutti i giorni, ci apprestavamo a circondare Antonio, ma, contrariamente al solito, lui si staccò da Ceresa e Piacentini i quali, a loro volta, si staccarono dal nostro gruppo con un atteggiamento imbarazzato e confuso; tenevano la testa bassa.
I più vicini a Gramsci erano Tulli e Lisa che, sperando di avviare la discussione, gli rivolsero la parola. Ma Antonio ebbe una reazione violentissima: "Basta, non discuto più niente, non riprendo nessuna conversazione!" Qualcuno ha riferito che egli avrebbe detto: "Smettiamola perché è una attività disgregatrice e frazionista." Ma Antonio non ci aveva proposto di fondare un nuovo partito e quindi non c'era frazionismo né da parte sua né da parte nostra che ci sentivamo pienamente nel partito. Qualcun altro ricorda che invece le sue parole furono: "Nelle celle la discussione va assumendo caratteri denigratori, calunniosi e scissionistici." Ma non c'era da scindere proprio niente; noi eravamo una collettività sui generis, non un collettivo politico organizzato e quindi non c'era da allontanare nessuno né dal cortile, né dalle camerate, né dal partito, perché non avevamo l'autorità per farlo, né le condizioni esistevano. Ognuno di noi poteva considerarsi il partito.
Certo, alcuni di noi ritenevano che quella di Gramsci fosse una posizione fuori della linea del partito, della linea cosi come l'avevamo lasciata o come ci risultava dai difficili rapporti con l'esterno che avevamo allora. Perciò non si fa un favore a Gramsci dicendo che tutto è degenerato sul terreno della calunnia; i termini che si usarono per definire le posizioni costituentiste non erano calunnie, erano aggettivazioni. Cosi come erano aggettivazioni i termini usati per controbattere le posizioni anticostituentiste. Ma tutto finiva li. Non c'era da sbattere fuori nessuno; nessuno, a Turi, avrebbe osato sbattere fuori Gramsci né dalle celle, né dai collettivi, né dal partito. Comunque Gramsci ruppe i rapporti con tutti, salvo che con Piacentini e Ceresa. Troncò anche con Lo Sardo e Tulli, che pure erano costituentisti. Si isolò.
Mantenne qualche contatto con Lai e Spadoni, ma non si trattava più di conversazioni politiche; Spadoni era un compagno generoso e buono ma non era molto ferrato su questi problemi, si stava formando allora. Per rompere questa situazione di stallo cercammo di sfruttare i vecchi rapporti di amicizia che lo legavano a Tulli dai tempi di Milano, a "l'Unità" e poi a San Vittore. Anche Lo Sardo e Lisa sarebbero stati adatti a questo compito, ma Lo Sardo era molto ammalato e Lisa si era troppo scoperto sostenendo con intransigenza le tesi che poi si rivelarono coincidenti con quelle ufficiali del partito.
Volevamo stabilire che ciò che gli avevano riferito era stato riferito male, in buona o cattiva fede. Ma Gramsci respinse ogni approccio. Per tornare a Ceresa e Piacentini io credo oggi che essi abbiano agito in buona fede. Erano dei neofiti del partito e si erano spaventati nell'udire un dibattito tra comunisti cosi acceso e spregiudicato. Per loro era inammissibile che Gramsci potesse assumere una posizione sbagliata; avevano un culto ingenuo della personalità nei suoi confronti.
Certo Gramsci per il suo valore meritava rispetto da parte di tutti i compagni; ma per loro, che si erano appena staccati dagli anarchici e, trovandosi soli con Antonio, avevano avuto da lui amicizia e aiuto soprattutto dal punto di vista culturale, le nostre posizioni erano inconcepibili, ereticali, scandalose.
Quando anche il tentativo di Tulli fu respinto — se si fa eccezione per Ceresa e Piacentini — tutti i compagni, compresi quelli che politicamente avevano sostenuto le tesi di Gramsci, non approvarono il suo modo cosi reciso di respingere ogni contatto, il suo risentimento e il suo rifiuto di ascoltare sia la relazione collettiva sia le nostre puntualizzazioni. Ci accingemmo cosi ad attendere che egli decidesse di rivelarci senza interposta persona ciò che gli era stato riferito; non per fare delle rappresaglie contro Ceresa e Piacentini, perché non eravamo su questo piano (infatti tra noi e loro due, dopo la rottura dei rapporti, non ci furono né occhiatacce, né invettive).
Ma anche questa possibilità non ci fu data e i rapporti si deteriorarono: c'erano solo i saluti a mezza bocca, niente più conversazioni né con Antonio, né tra di noi. li suo isolamento aveva investito un po' tutti. Soffrivamo di questa situazione e credo soffrisse anche Antonio. Recentemente, parlando con Pertini, egli mi ha espresso tutto il suo rammarico per quel periodo che poteva essere proficuo per tutti noi e che, invece, per questa divisione tra i compagni, fu sterile, se non dannoso.
Trascorsero varie settimane, ma la situazione diveniva sempre più pesante. Poi ci fu l'arrivo di Tosin e le notizie che egli portò dall'esterno ci confermarono che in Gramsci c’era stato un progressivo distacco dalla linea ufficiale del partito.
Quando Tosin venne nel cortile, la scena era quella consueta di dopo la rottura: Gramsci da una parte con Ceresa e Piacentini, noi dall'altra. Qualche guardia ci aveva preavvertito dell'arrivo di questo nostro compagno, ma nessuno di noi lo conosceva.
Tosin salutò tutti. Poi Gramsci lo prese sotto braccio, lo trasse in disparte e si mise a passeggiare con lui ponendogli tante domande. Più tardi, in cella, Tosin ci raccontò come candidamente egli avesse riferito della situazione all'esterno e della espulsione dei "tre," e come Antonio fosse rimasto profondamente scosso da questa notizia e dai particolari sulla "svolta."
Alla luce delle cose riferite da Tosin apparve che noi eravamo in linea e che la posizione di Gramsci era fuori dalla linea del partito; devo dire però che nessuno tra noi ricavò da questa situazione un atteggiamento di rivalsa. Certo sarebbe ipocrita non riconoscere che provammo un'intima soddisfazione, ma solo per il fatto che, pur essendo isolati, avevamo intuito qual era la posizione giusta. "Il partito ha sempre ragione," pensavamo, e sentivamo di avere un motivo di più per chiedere a Gramsci di continuare a discutere al fine di chiarire tutto.
Ma ogni tentativo fu ancora inutile.
Io mi stancai di questa situazione e con me anche Lisa, Lo Sardo, Reggiani ed altri; ci sentivamo a disagio. Ne parlai anche con Lai quando dal camerone fui riportato in cella: "Non m'importa di guarire," gli dissi, "ma in questa situazione non riesco a reggere più; diminuisco di peso, sono insoddisfatto. Tra noi ci guardiamo in cagnesco, non si può fare scuola di partito, non si può migliorare, perciò chiedo il trasferimento." Anche Reggiani era del mio stesso parere: "Lasciamo tranquillo Gramsci e andiamocene tranquilli noi!"
Cosi, cominciò l'esodo. Partimmo io, Reggiani, Tulli, Riboldi. Poi alcuni di loro tornarono perché nelle altre case di pena si stava male.
Riboldi nel suo libro (Vicende socialiste. Trent’anni di storia italiana nei ricordi di un deputato massimalista, Ediz. Azione Comune, Milano, 1964) racconta che in seguito il clima tornò più sereno; ricominciarono le conversazioni con Gramsci, non ci si accani più su quei temi che avevano diviso i compagni. Anche Clementi mi ha confermato a voce recentemente queste cose.
Vorrei aggiungere alcuni altri ricordi che mi sembrano interessanti e che esulano dalla disputa sulla fase intermedia e la Costituente. Antonio non ci fece mai lunghe trattazioni sui problemi internazionali. Soprattutto non si espresse mai contro la politica ufficiale sovietica. È chiaro che sull'URSS egli si era fatto un'opinione ma con noi non espresse mai apprezzamenti critici sui problemi di quel paese. Ricordo però che in carcere circolava La mia vita di Trotski e che, prima della rottura del nostro gruppo, se ne parlava nelle ore dell'aria perché quasi tutti noi avevamo letto questo libro. Su Trotski, un giorno, Gramsci disse: "Grande storico, grande rivoluzionario, ma è un egocentrico, vede se stesso al centro di tutti gli avvenimenti, non ha il senso del partito." E sempre a proposito di Trotski e del termine bonapartismo che ricorre nelle sue accuse a Stalin e alla politica ufficiale del Partito bolscevico, Antonio diceva: "Non si può parlare di bonapartismo in senso deteriore quando si pensi che Bonaparte non è stato il soffocatore della rivoluzione borghese, ma colui che ha portato la stessa rivoluzione alle conseguenze possibili, anzi l'ha dilatata, anche se essa ha poi deluso le aspettative del nascente proletariato. Napoleone è stato l'ultimo capo della borghesia rivoluzionaria in Francia. Quindi il termine bonapartismo non ha senso se lo si trasporta dalla Francia in Unione Sovietica perché là c'è ancora il regime che è sorto dalla rivoluzione bolscevica." Questo non vuol dire neanche che Gramsci bruciasse incenso sull'altare di Stalin.
Oggi, facendo i conti dopo quasi quarant'anni, io mi domando "Che cosa è ancora vivo di Gramsci?" E la risposta è immediata: "Tutto è vivo di Gramsci."
Io non sono più nel Partito comunista; dopo aver affrontato la vita illegale nel 1932-33/ ruppi il mio rapporto nel 1934; ero ancora sulle posizioni svoltiste. A distanza di tanto tempo, dopo tante peripezie, tanti errori, nonostante dal 1945 a oggi abbia avuto un ripensamento positivo, credo che non si possa tornare indietro, rifarsi una verginità; dopo una decina d'anni di deviazioni personali grosse e dolorose, non si può riessere ciò che si è distrutto.
Ma si può ricreare, ci si, deve rialzare; altrimenti vuol dire che non si era niente neanche prima. Cosi mi sono ributtato nelle lotte, milito nella sinistra italiana tenendo sempre presente questa grande prospettiva che ci si purifica e ci si migliora nell'azione. È inutile buttarsi in ginocchio con autocritiche formali. Io credo nell'obiettivo del l'unità organica sia in campo sindacale che in campo politico e che ad esso dobbiamo tendere lasciando indietro tutte le scorie e le amarezze della nostra vita.
Gramsci è oggi sempre più attuale: nella scuola, nelle lotte sociali, ma soprattutto nell'esigenza di abbandonare i settarismi e gli schematismi che sono stati tanta parte della vita di alcuni di noi. Egli è il primo che abbia indicato non solo al Partito comunista ma a tutto il movimento operaio, ai rivoluzionari in Italia e in Europa, le vie nazionali al socialismo che sono veramente scaturite dalla sua passione, dal suo ingegno.
Questa è una delle cose più vere che si possano dire di lui tra le tante cose vere che si potrebbero dire; e ci dispiace di non potergli chiedere scusa per le escandescenze giovanili e per i nostri errori. Ma Gramsci era superiore a tutte queste cose.
BRUNO TOSIN
Bruno Tosin, vicentino, si iscrisse al Partito comunista italiano dalla fondazione, nel 1924; come segretario della federazione vicentina partecipò a Fratta Polesine ai funerali di Giacomo Matteotti. Dopo il primo arresto nel 1926 lavorò come elemento tecnico presso la segreteria del partito a Roma, quindi frequentò a Mosca il primo corso leninista fino al 1928. Rientrò in Italia nel 1930 per svolgere il lavoro di partito in Piemonte e in Liguria, ma venne subito arrestato. Dopo il carcere lavorò a Parigi alla "Voce degli italiani." Fu preso dai tedeschi e portato a Fresnes. Combatté in seguito coi partigiani francesi. Dopo la Liberazione fu segretario della federazione comunista di Vicenza e in seguito fu chiamato a Roma da Di Vittorio come collaboratore alla segreteria della CGIL. Pubblicò, nel 1976 <Con Gramsci – Ricordi di uno della ‘vecchia guardia’>, Editori Riuniti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
La prima volta che vidi Gramsci era presente anche Scoccimarro e ci limitammo a salutarci. Successivamente invece ebbi modo di stare con lui e Scoccimarro per un paio d'ore quando ci fecero una specie di lezione prima di partire per la scuola del partito a Mosca. Poi andai a Mosca. Rientrai in Italia nel 1929 per svolgere il lavoro di partito nell'illegalità. Fui arrestato con la Ravera. Quando mi visitarono dopo la condanna insistettero nel dire che avevo avuto un processo di tubercolosi e mi mandarono immediatamente a Turi di Bari, senza farmi passare attraverso il periodo di isolamento.
Arrivai a Turi nei primi giorni di dicembre del 1930. Naturalmente, il fatto di andare a Turi e di incontrarmi nuovamente con Gramsci era per me un avvenimento.
Dopo le solite visite e le solite vestizioni, mi mandarono nella cella n. 2, che era relativamente vicina a quella di Gramsci; c'era solo una specie di balconata che le separava. Li trovai altri compagni, fra i quali il nostro bravo avvocato Riboldi, Scucchia e non ricordo ora con precisione gli altri, ma mi pare che ci fosse anche Lai.
Poiché non era ancora l'ora del passaggio, io domandai subito come stava Gramsci. Mi risposero che stava poco bene. Allora domandai com'era la situazione e mi dissero: "Non è buona, vedrai da te, non vogliamo suggerirti niente."
La mattina successiva andammo al passeggio e la prima cosa che feci naturalmente fu quella di andare incontro a Gramsci, che era completamente cambiato. A parte il fatto che era rasato, gli mancavano i denti davanti e aveva la faccia vizza come una mela vecchia. Si vedeva che non stava assolutamente bene.
Per due giorni consecutivi Gramsci praticamente mi prese da parte e volle sapere cosa faceva il partito. Dato che io avevo lavorato accanto alla segreteria con Togliatti e la Ravera, avevo la possibilità di informarlo su tutti gli avvenimenti, compresa l'espulsione dei "tre": Ravazzoli, Tresso e Leonetti. Lui insisteva molto per sapere e, sia il primo mattino che quello dopo, ritornò sull'argomento dell'espulsione, chiedendomene i motivi. Il primo giorno, siccome i "tre" erano membri dell'ufficio politico, mi aveva chiesto come mai erano finiti nell'ufficio politico dato che secondo lui non erano elementi cosi validi da arrivare a un posto di responsabilità come quello. Insistette in modo particolare per sapere qual era stato l'atteggiamento di Tresso. Seppi poi che Tresso era stato uno dei suoi allievi, al quale aveva dedicato particolari cure. Il mattino successivo tornò su questa questione e volle sapere con esattezza perché erano stati espulsi. Io, che glielo avevo già spiegato il giorno prima, gli ripetei che non si trattava del fatto che loro si opponevano alla politica del partito. La loro espulsione era stata originata più che altro dal fatto che, mentre discutevano ancora con Togliatti e con la maggioranza del partito sull'opportunità o meno di rientrare in Italia, essi avevano già cominciato a scrivere sul settimanale trotskista di Parigi; e già prima del provvedimento contro di loro erano apparsi su quel giornale degli articoli senza firma, ma praticamente si era saputo chi li aveva scritti. Cosi che, quando c'era stata la riunione del comitato, che aveva deciso la loro espulsione, non avevano nemmeno partecipato. Soltanto Tresso era presente e mi ricordavo che tanto Grieco che Di Vittorio avevano insistito molto con lui perché rimanesse nel partito, perché si staccasse dalla posizione degli altri.
In effetti la posizione di Tresso non era come quella degli altri due: Tresso non era cosi ferocemente antitogliattiano come Ravazzoli e Leonetti.
Intanto, in quei due giorni, i compagni di cella mi avevano spiegato quali erano stati i termini della discussione con Gramsci e mi dissero che praticamente c'era stata una rottura all'interno del nostro gruppo di prigionieri.
Il giorno successivo io credevo che Gramsci volesse continuare a parlarmi e invece si staccò completamente. Gli si misero accanto quei due milanesi, i due ex anarchici, coi quali pare che andasse d'accordo in quel momento, mentre con i compagni era completamente in rotta. Questo mi fece male, non perché mi avesse allontanato, ma perché dovetti ammettere che davvero si era creata una divisione netta fra Gramsci e gli altri. Gramsci stava solo con quei due e parlava solo con loro, gli insegnava a diventare dei compagni. Uno di loro infatti, il Ceresa, è diventato poi un bravo compagno, l'altro non so che fine abbia fatto. Con tutti gli altri, compresi Lai, Scucchia, Riboldi e il povero Lo Sardo, che era uno di quelli che gli erano stati più vicini, deputato anche lui, di Messina, non aveva più nessun rapporto.
Nei giorni successivi mi sorprese ancora di più il fatto che mentre con qualche compagno, ad esempio con me, scambiava i saluti magari da lontano, con altri come Tulli e Lo Sardo non si davano nemmeno il buongiorno. Su Tulli aveva ragione. Per quanto riguarda Lo Sardo invece io volli ad un certo punto chiarire la ragione di questa inimicizia che pareva più personale che politica, ma Lo Sardo non volle dirmi niente. Mi rispose: "Bisogna avere pazienza, Gramsci non sta bene, è ammalato."
Anch'io ero arrivato in carcere con tutte le illusioni dell'epoca, avevo vissuto la lotta che c'era stata contro quelli che non volevano si facesse il lavoro in Italia, avevo creduto come altri che in Italia ci fosse la possibilità di ottenere dei risultati rapidamente. È vero che a questo fine avevo lavorato per poco tempo, perché in Piemonte ci arrestarono subito come illegali, ma credevo di aver constatato che ci fosse la possibilità di muoversi rapidamente, anche se le forze erano poche. Ora i compagni mi dicevano che Gramsci escludeva la possibilità di movimenti di mas: sa, non dico di movimenti rivoluzionari, ma che portassero almeno a estendere la nostra influenza non solo tra gli operai, ma fra le masse in generale. Quindi mi fu un po' difficile il rapporto con Gramsci. Mi aspettavo infatti che lui cercasse di discutere anche con me quel problema che già aveva discusso con gli altri compagni e che aveva portato alla rottura. E invece Gramsci, anche se occasionalmente scambiava qualche parola con me, dava l'impressione di non voler affrontare una nuova discussione; certamente l'aveva urtato il fatto che i compagni non fossero nella maggioranza d'accordo con lui. D'altra parte ebbi l'impressione che lui avesse paura in un primo momento di scoraggiarmi. Io infatti gli avevo parlato del lavoro e delle previsioni del partito che erano contrarie a quelle che erano le sue previsioni. Quindi penso che volesse un po' alla volta convincermi, non affrontando direttamente il problema, come aveva fatto con gli altri, ma attraverso certi episodi e certe discussioni che potevano accadere incidentalmente e in cui anche lui era spesso coinvolto.
Anche se stavo con gli altri, trovavo spesso il modo di porgli una questione o un'altra, per aver modo di avvicinarlo o anche per sentire semplicemente la sua opinione. Una opinione, per esempio, che si manifestò nei primi giorni, fu questa: non era d'accordo con un certo numero di compagni che a Natale, a Pasqua o nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma, si rifiutavano di ricevere i pacchi viveri da casa o rifiutavano anche del tutto il cibo: la pastasciutta o il bicchiere di vino che passava il carcere. Lui diceva: "Noi dobbiamo uscire dal carcere in condizioni di poter lavorare per il partito, e se non mangiamo, se ci rifiutiamo di mangiare, se facciamo gli scioperi della fame (anche avessero una motivazione fondata) usciremmo ammalati e invece di essere di aiuto al partito, sarà il partito che dovrà mandarci in case di riposo e di cura."
Questa sua opinione, sulla quale ero d'accordo sin dal primo momento, mi tornò alla mente quando, dopo il periodo di Turi, arrivai ad Ancona e mi trovai di fronte ad un'agitazione con uno sciopero della fame in corso. Ma il ricordo che voglio sottolineare è che io non ero convinto di quello che Gramsci aveva detto agli altri compagni e che di riflesso o direttamente io avevo sentito. E non ero nemmeno d'accordo di continuare in quella situazione in cui ci trovavamo nel carcere. Mi domandai che cosa si poteva fare per migliorarla; di fronte al capo del partito, al quale dovevo rispetto, non dico obbedienza perché eravamo compagni, mi trovavo in difficoltà.
Un giorno i compagni mi dissero che c'era la possibilità di comunicare qualche cosa al centro estero e, anche dietro loro consiglio, mandai fuori un biglietto dove dicevo che Gramsci non era d'accordo con la posizione del partito, che la situazione nel carcere era quella che era, che si era a una divisione completa e che io non sapevo che cosa fare per migliorare le cose e che aspettavo da loro delle indicazioni.
Non ricevemmo risposta; nel frattempo qualcuno aveva detto a Gramsci che io avevo spedito fuori questo messaggio. Una mattina mi chiamò da parte e mi chiese se era vero. Io dissi di si. Mi chiese cosa conteneva il biglietto e siccome erano poche parole, io gliele ripetei quasi letteralmente. Allora lui mi invitò a mandare un'altra lettera, in cui dovevo dire di non tenere conto della prima e che avrei riscritto. In questa occasione aggiunse che probabilmente, quando avessimo avuto una risposta, lui stesso avrebbe scritto qualche cosa al partito per esprimere la sua opinione. Anche questa volta non mi risposero, passò il tempo e non ebbi più il coraggio di ricordare a Gramsci questa sua promessa. Anche perché il fatto che non avevamo ricevuto risposta dimostrava che probabilmente la lettera non era giunta. Nel frattempo, però, dopo l'arrivo di Clementi, i rapporti erano un po' migliorati. Tanto è vero che con Gramsci eravamo d'accordo che lui avrebbe ripreso le conversazioni, non su temi politici, ma di istruzione generale. Lui avrebbe fatto delle lezioni sul movimento internazionale, io avrei potuto fare qualcosa sulla geografia politico-economica dei paesi dell'Europa, e qualche cosa anche sul movimento internazionale, per quanto ricordavo della scuola di Mosca.
Lui aveva detto che bisognava attirare in queste discussioni, non solo come allievi ma anche come insegnanti, altri compagni. Non se ne fece nulla e passarono dei mesi. In aprile mi chiamarono per una visita che credevo di controllo, ma non mi fecero sapere niente, e invece una mattina mi dissero di preparare i bagagli. Ebbi appena il tempo di salutare i compagni che erano in cella con me. Salutai Gramsci, che si mostrò molto dispiaciuto attraverso il finestrino della cella dove era rinchiuso e davanti al quale ero costretto a passare per scendere verso l'uscita.
Ci lasciammo con un arrivederci che purtroppo non è stato, perché Gramsci è finito come è finito.
Non posso dire che Gramsci fosse sempre serio e immusonito; molto spesso si sforzava di mostrarsi allegro: ad esempio, quando si metteva a canterellare canzoncine come quella "A me non piace la merda squacchera perché pillacchera, perché pillacchera..." Oppure in altre occasioni, quando raccontava episodi avvenuti nella sua provincia. Raccontava di certe donne fattucchiere e medichesse e di un ragazzo che era pieno di rogna sulla testa e che invece che dal dottore era stato portato appunto dalla fattucchiera. Questa gli aveva messo in testa un impasto di catrame, l'aveva poi lasciato seccare e quindi l'aveva strappato improvvisamente portando via pelle e capelli e scotennando questo povero ragazzo, che dovettero poi portare in ospedale perché era rimasto col cranio completamente rasato. Oppure altri racconti sulla vita del carcere.
A Turi c'erano diversi ergastolani sardi. Quando andavamo al passeggio, i primi ad uscire erano i sardi comuni (c'erano due gruppi distinti: politici e comuni). Lui spesse volte si affrettava perché i comuni camminavano piano, ce n'erano alcuni che andavano col bastone, li raggiungeva e si metteva a chiacchierare con loro e poi ci raccontava certi episodi di questi poveri disgraziati.
Uno, per esempio, diceva: "Si sta bene qui, piuttosto che in manicomio." Erano trent'anni che era lì! Aveva tagliato la testa al prete del suo paese, ma la testa non si era più trovata. Solo quando lo arrestarono scoprirono dov'era nascosta. Infatti lui stesso li aveva portati sul posto, aveva smosso un masso e, scavando, avevano trovato la testa del prete. Gli chiesero perché avesse fatto questo e lui aveva risposto: "I preti sono cosi furbi che se non gli avessi tagliato la testa e poi non l'avessi nascosta, sarebbe stato capace di andare a cercarla per rimettersela a posto." Questo significava che l'ergastolano era effettivamente pazzo ma che aveva avuto la fortuna di finire in una casa di pena, piuttosto che al manicomio.
Gramsci ci raccontava anche la vicenda di un altro. Camminava con due bastoni e se non li avesse avuti era cosi curvo che avrebbe toccato terra con il mento. Costui aveva altre ragioni per essere nel carcere di Turi. Prima era stato arrestato per delle questioni da poco: abigeato semplice, una o due pecore, poi era uscito e aveva finito per ammazzare qualcuno di quelli che avevano testimoniato contro di lui nel primo processo e anche uno dei giudici o dei giurati. Però era soddisfatto perché se lui si trovava in carcere da più di trentanni, a tutti gli altri era andata anche peggio, perché erano morti: il pubblico ministero, l'avvocato difensore, tutti i testimoni a carico e quelli a discarico. Erano morti insomma tutti quelli che avevano assistito per una ragione o per l'altra al suo processo. Lui era in. carcere, ma era ancora vivo.
Gramsci si divertiva a raccontarci questi episodi quando si riuniva al nostro gruppo dopo aver salutato i suoi compatrioti ergastolani. Parlava come se fosse contento della resistenza fisica di questa sua gente. Uomini che avevano 80, 85 anni, che erano in carcere da oltre 30 anni, ma che erano ancora vivi, erano forti, forse un po' "fuori" con la testa, ma vivi.
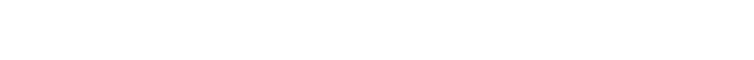
Lettere dal carcere, a cura di Sergio Caprioglio e Elsa Fubini, Torino, Einaudi, 1965
Lettere dal carcere 1926-1937 (1947) Sellerio, Palermo 1996 (contiene tutte le lettere - 478 testi, 50 in più di quelle della prima edizione einaudiana)
Sui tentativi di liberare Gramsci per via diplomatica cfr. Gramsci in carcere e le autorità sovietiche, in « Il Calendario del popolo» , aprile 1988, pp. 12483-12487.

l'ingresso della cella di Gramsci a Turi