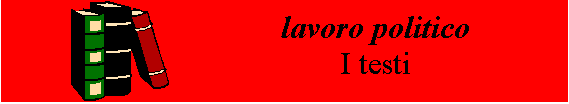
|
Centro Studi e Documentazione marxista |
||
|
Pubblicazioni di Ferdinando
Dubla |
||
| Riproduciamo
integralmente la dispensa seminariale frutto del lavoro di
elaborazione del collettivo del circolo PRC "Secchia" di
Leporano (TA) [scioltosi nel 1998] e curata da Ferdinando Dubla nel
1996. Il formato a stampa è per i tipi della TIMMA e può essere
richiesto al Centro per euro 7,75 (£.15.000)
| ||
CIRCOLO PRC“PIETRO SECCHIA”Leporano (TA) dispensa seminariale circolo
PRC “P. Secchia”
Leporano (TA) (a
cura di Ferdinando Dubla) 1996 In Italia, ma non solo, la fortuna di Guevara è legata ad una certa suggestiva iconografia, che negli anni ha fatto prevalere l’immagine tipologica ad un approfondito studio dei testi, dei suoi testi e opere e della cosiddetta letteratura “critica”. Non che quella simbologia abbia arrecato danni, tutt’altro: se il mito è positivo, l’emblema non può che raffigurarne il fulgido esempio e ispirare lotte coerenti, infondendo coraggio: così nel ‘68, la figura del rivoluzionario latinoamericano ha rappresentato l’aspirazione alta alla liberazione dal capitalismo per una generazione intera di militanti, che è stata trasmessa, seppur modificata, fino ai giorni nostri. Così come il mito di Spartaco, l’esempio di Guevara è tutt’uno con l’idea stessa di comunismo. Dal
1992, venticinquesimo anniversario della tragica morte in Bolivia
(che avvenne il 9 ottobre 1967) del guerrigliero di origine
argentina, in avanti, si sono succeduti numerosi incontri e
convegni
nell’ambito della sinistra di classe e meritorio ruolo è stato
svolto da Roberto Massari e dalla sua casa editrice Erre Emme, che
ha dedicato a Guevara diverse iniziative editoriali (non scritte
certo per l’occasione, fuori cioè da una possibile momentanea
“moda”), e sia lavori più generali sulla storia di Cuba e sul
marxismo latinoamericano. (1) Abbiamo
visto riproporsi, molto negativamente, alcuni stereotipi che hanno
accompagnato l’immagine del “Che” in tutti questi anni: quello
del comunista “umanista”—libertario, attento alla dimensione
dell’individualità nell’ambito del pensiero marxista (di cui
riprenderebbe le suggestioni e le analisi giovanili, quelle dei
“Manoscritti” del 1844, per intenderci), contrapposto al comunista di tradizione leninista, impersonificato
nell’effettiva realizzazione del socialismo a Cuba ad opera di
Fidel Castro e del successivo stretto legame con l’Unione
Sovietica e in genere con il movimento di ispirazione
terzinternazionalista, differenza che si renderebbe davvero
palpabile solo dopo lo sbarco dei fuoriusciti cubani sostenuti
dall’imperialismo nordamericano nella Playa Giròn,
nell’aprile 1961 e quindi dovuta all’immersione nei problemi
concreti dell’edificazione del socialismo, susseguenti anche
alla “crisi dei missili” dell’ottobre ‘62. Si spiegherebbe
così, dopo la vittoria del gruppo della Sierra Maestra che riesce
a por fine alla sanguinaria dittatura di Batista (1959), la volontà
di Guevara di abbandonare i prestigiosi incarichi statali (era
stato ministro dell’industria dal 1961 al ‘64, nonché
rappresentante internazionale del nuovo governo rivoluzionario
cubano) e tentare l’avventura boliviana, che doveva costargli la
vita. I
testi di Massari non rendono
giustizia di questi stereotipi ma, anzi, finiscono (a volte
direttamente, a volte indirettamente) per avvalorarli. Abbiamo cioè
l’impressione che l’opera complessiva del Che venga ancora
analizzata con lenti per una lettura precostituita, più per
l’impatto che il suo esempio ha avuto nell’immaginario
collettivo della sinistra rivoluzionaria (oggetto d’indagine
importantissimo, sia chiaro, ma che ancora deve realmente essere
condotto), che riveniente invece da uno studio filologico e della
sua azione e delle sue teorizzazioni. Individuiamo
alcuni nuclei tematici: a)
l’ideale dell’unità antimperialista latinoamericano b)
i problemi della tattica e della strategia rivoluzionaria
(che richiama quello del rapporti tra princìpi e creatività
nel fuoco della lotta concreta) c)
il
tema dell’alienazione e della formazione della coscienza di
classe, oltre (ma non fuori) l’oggettività dei fattori economici e la più
rigorosa analisi delle classi sociali, questioni strettamente
intrecciate alla società di transizione e alla costruzione del
socialismo. Solo
se si tiene fermo il primo punto, e cioè la necessità di
controbattere il "globalismo" dell’imperialismo affamatore dei
popoli e fautore della guerra, con l’unità politica del
continente sudamericano, dunque con una strategia di mobilitazione
permanente contro ciò che viene considerato il fattore
determinante per la riproduzione dell’iniqua divisione del
lavoro sociale a livello planetario e, nel caso,
sub—continentale, può comprendersi la scelta di Guevara, che
non è degli ultimi anni: egli, argentino, si è formato nella
stessa Bolivia e nel Guatemala di Arbenz, ha sposato una prima
volta una peruviana (Hilda Gadea) in Messico; è a Città del
Messico che incontra per la prima volta Fidel, reduce dalla
battaglia contro la caserma “Moncada” e con lui, insieme ad
altri 81 uomini, organizza, il 2 dicembre 1956, lo sbarco del “Granma”,
poi la resistenza sulla Sierra Maestra e la vittoria decisiva di
Santa Clara, la “città dai mille tetti rossi”, che lo vide
entrare trionfante insieme a Camilo Cienfuegos, il primo martire
della rivoluzione, dopo aver attaccato e fatto deragliare il treno
blindato di Batista. Lo
stesso Castro chiarirà questo punto, anche in anni recenti, nel
discorso commemorativo da lui tenuto a Pinar del Rio (provincia
emblematica, lo ricordiamo per inciso, dato che lì era avvenuto
i1 sabotaggio, uno dei più criminali, delle miniere di Matahambre),
l’8 ottobre 1987: “Né
si deve trascurare l‘insistenza con cui il Che volle esaudire un
suo antico desiderio, una vecchia idea, di ritornare
nell‘America del Sud, nella sua patria, per fare la rivoluzione,
con tutta l‘esperienza acquisita nel nostro paese (…) ho
spiegato quali fossero le origini di quell‘idea, come, nel
momento in cui si era unito a noi, egli avesse posto una sola condizione: che una volta realizzata la
rivoluzione, nel momento in cui egli avesse voluto fare ritorno in
Sudamerica non sarebbero sorte obiezioni o ragion di stato tali da
interferire con quel desiderio, che non gli sarebbe stato
impedito. (...) Non solo
venne mantenuta la promessa di acconsentire alla sua partenza, ma
lo si aiutò per quanto possibile a realizzare 1‘impegno”. Quanto
alla formazione teorica, sia Castro che Guevara diventerebbero
incomprensibili senza il legame strettissimo che deve porsi con
Simon Bolivar e Josè Martì: ma ricompresi con l’assimilazione
del marxismo, che anzi agli inizi era più forte nel Che che in
Fidel. Un marxismo che riverberava potente nella guida
dell’azione pratica: dunque al servizio di una rivoluzione
concreta,
e per questo leninista, che internazionalmente non poteva non
collegarsi all’Ottobre sovietico. Da
qui l’insistenza, sempre presente nel guerrigliero e uomo
d’azione, ma personalità riflessiva e metodica
caratterialmente, nonché attento studioso dell’analisi
marxiana, alla fermezza nei princìpi teorici del marxismo e del
leninismo e alla coerenza fra princìpi e strategia per il
comunismo. Egli giudicava gli avvenimenti secondo questi parametri
non spiegabili per le apparenze contingenti, per cui il rapporto
tra tattica e strategia, diventava funzionale al nesso princìpi/creatività: nell’indissolubilità delle correlazioni
tra questi, era inscritta la possibilità della vittoria contro
l’imperialismo e, in generale, contro l’organizzazione
capitalista della società e le sue sofisticate sovrastrutture
ideologiche (vedi la legge del valore—lavoro e il “valore”
ideologico che può ancora funzionare in una struttura socialista
e, comunque, di transizione) per il dominio oligarchico, che
tendevano ad offuscare la coscienza di classe. É in questa
complessità, teorica e di prassi rivoluzionaria nello stesso
tempo, che si inquadra la prefazione che Guevara scrive nel 1963
al “Manuale” di marxismo—leninismo di Kuusinen, leader del
comunismo finlandese, legato strettamente ala cultura
cominternista (tanto da essere definito “mastino” dello
stalinismo, secondo le solite etichettature di comodo che, anche a
sinistra, fanno da schermo all’analisi scientifica) che provoca
l’”indignazione” di Massari, volta invece a dimostrare la
consonanza tra le concezioni trotskiste e il Che, confortata anche
dal fatto che gli fu trovato nel marzapane, alla sua morte, una
copia de “La storia della rivoluzione russa” di Trotsky. In
quella prefazione, che va inquadrata in tutto l’operato di
Guevara e non “stralciata” dalla sua biografia intellettuale,
egli difende il ruolo d’esempio e guida del PCUS e dei partiti
fratelli marxisti e leninisti di tutto il mondo e, in modo tutto
personale e suggestivo scrive che “I marxisti devono essere i migliori, i più capaci, i più completi degli esseri umani (..) militanti di partito che vivono e sentono con le masse; orientatori che plasmano in direttive concrete i desideri qualche volta oscuri delle masse; lavoratori infaticabili che danno tutto di se stessi al loro popolo, che sacrificano alla Rivoluzione le loro ore di riposo, la loro tranquillità personale, la loro famiglia e perfino la loro vita, ma che non sono mai indifferenti al calore del contatto umano” (III, 61). E ancora nell’aprile 1965, ne “Il socialismo e l’uomo a Cuba” il Che espone in forma sistematica il proprio ideale di “partito operaio”, non molto diverso dai modelli storici della tradizione leninista: partito
d’avanguardia; ammissione selettiva; minoranza di quadri
formati; impegno ad elevare il livello delle masse; comunismo come
programma (in realtà come ideologia); carattere esemplare e
pedagogico della militanza; spirito di abnegazione e sacrificio. Nessuna
incoerenza, dunque, semmai sembra che non ci si renda conto che il
tema dell'etica comunista è tutt’intero inscrivibile nella
concezione guevariana della massima fermezza dei princìpi teorici
(che sono quelli del marxismo più conseguente e del leninismo
assunto come filosofia dell’azione “coerente ai princìpi”) e
della loro applicazione alle situazioni specifiche. Applicazione
concreta, non fumisteria ideologizzante, si badi: e qui si tocca
lo spinoso problema dell’utopia, anzi, del mito dell’utopia. Guevara
è consegnato in qualche modo, negli studi di Massari, come
anche in altri interventi di tendenza, alla tradizione dei
pensatori utopistici: ora, lo slancio ideale nella progettazione e
costruzione della società socialista, è presente nello stesso
Marx e in tutti i teorici del comunismo che da lui prendono le
mosse; ma, certo, in polemica con l’utopismo, che è corrente
ben presente nel movimento operaio sin dalle origini e contro cui,
come si sa, sia Marx che Engels combattono nella I Internazionale All’avversario
di classe, va contrapposta un’analisi scientifica della società,
delle classi sociali, della struttura economico-produttiva e non
lo sterile sogno che si frantuma nelle asperità del presente (la
‘New Harmony’ e i ‘falansteri’ di Owen e Fourier).
Caratteristica della carica utopica del “Che” sarebbe
individuabile soprattutto nel tema dell’alienazione, e che
costituirebbe
il sottofondo teorico della critica ai paesi del socialismo
realizzato nella celebre Conferenza di Algeri dei 1965. A noi
sembra invece che proprio lo stretto legame che così viene a
instaurarsi tra il pensiero guevariano e la teoria del giovane
Marx, ponga la critica alle esperienze delle società socialiste,
a cui non viene mai meno l’appoggio di fondo contrapposto
all’imperialismo guerrafondaio, su un terreno di molto più
avanzato che quello della semplicistica categoria della
‘degenerazione burocratica’ a cui sembra molto legato Massari. Innanzitutto,
proprio perché il comunismo deve configurarsi come società
superiore dal punto di vista dei rapporti sociali e umani (da qui
il suo “umanesimo socialista rivoluzionario” e non semplice
umanesimo idealistico) , non
può concorrere sullo stesso terreno e condividendo gli stessi
parametri di valutazione del grado di 'benessere' (altrimenti
funzionerebbe ancora la legge del valore), dell’organizzazione
sociale capitalista, ma su una più elevata coscienza, capace di
individuare l’autentica ricchezza sociale: “Noi
non concepiamo i1 comunismo come la somma meccanica dei beni di
consumo in una data società, ma come il risultato di un atto
cosciente; da ciò l'importanza dell‘educazione e, quindi, del
lavoro sulle coscienze degli individui nell‘ambito di una società
in pieno sviluppo materiale” (II,285). Il
socialismo come massima liberazione del soggetto storico
concreto, che è il proletariato e i ceti che il capitalismo rende
subalterni, sia materialmente che “fenomenologicamente”
attraverso i suoi feticci: “Il
socialismo economico senza la morale comunista non mi interessa.
Lottiamo contro la miseria, ma lottiamo al tempo stesso contro
l’alienazione” (intervista a Jean Daniel, luglio 1963) E
ancora: “Vincere il
capitalismo coi suoi stessi feticci, ai quali è stata tolta la
1oro caratteristica magica più efficace, il lucro, mi sembra un’impresa difficile” (lettera a
José Medero Mestre, febbraio 1964). (2) I diretti testi del grande rivoluzionario latinoamericano, dunque, fanno giustizia di molte interpretazioni ‘forzose’ del suo pensiero e della sua azione. Già novità di rilievo a questo riguardo, in Italia, è stata, nell’anno del venticinquesimo della sua tragica morte in Bolivia, la pubblicazione della sue ultime lettere a cura di Roberto Zanetti e realizzata dall’Associazione Italia-Cuba di Montagnana, per i tipi della Isonomia Editrice di Este (Padova). Ma anche qui, si tratta non di inediti; semmai pone il lettore comune, così come il ricercatore, davanti alla limpidezza del suo autentico messaggio rivoluzionario, come questo che è estratto dal Messaggio alla Tricontinentale, reso pubblico all’Avana il 17 Aprile 1967: “Nel nostro mondo in lotta, tutte le divergenze relative alla tattica, al metodo di azione per raggiungere obiettivi limitati, vanno analizzate con il rispetto dovuto alle opinioni altrui. Quanto al grande obiettivo strategico, la distruzione totale dell'imperialismo per mezzo della lotta, dobbiamo essere intransigenti. Le nostre aspirazioni, in sintesi, sono queste: distruzione dell’imperialismo mediante 1’eliminazione del suo baluardo più potente: il dominio imperialista degli Stati Uniti d’America. Come obiettivi tattici, assumiamo la liberazione graduale dei popoli, a uno a uno, e per gruppi, attirando il nemico in una lotta difficile fuori dal suo terreno, liquidando le sue basi di appoggio: i territori dipendenti”. La
novità più consistente, però, si è avuta nel 1994, dopo la
quale molti dei cliché sul Che Guevara non possono rimanere
inalterati. Si
tratta della pubblicazione del diario inedito scritto in
Africa, esattamente nel Congo lacerato dai colpi di stato
antilumumbisti ad opera dell’imperialismo, nel 1965, l’anno
che costituiva fino a quel momento, un vero “buco nero” nella
biografia del Che e che dette la stura a tutta una serie di
immaginifiche illazioni sul luogo ove egli si trovasse, a Cuba o
fuori di Cuba, vivo o morto, complice Fidel o addirittura Fidel
accusato di averne deciso l’esecuzione per via dei sempre
presunti, ricercati, insanabili contrasti dovuti di volta in volta
a molteplici fattori, con spiccata preferenza ai problemi dello
stretto legame con l’URSS, oppure a quelli fatti risalire alla
sua gestione ministeriale del settore industriale (e gli esempi
potremmo elencarli numerosissimi, perché è insuperabile la
creatività degli imperialisti quando scambiano e spacciano la
droga delle loro speranze con la realtà). (3) (4) Non
che il diario congolese aggiunga qualcosa di straordinario: -sulle
intenzionalità politiche del Che, testimonianza di Rivalta: “Il
Che parlò delle sue intenzioni con me prima di intraprendere la
missione. Il Congo poteva servire come base, cioè come
detonatore,
per rivoluzionare tutti gli altri paesi africani ed era essenziale
soprattutto per la sua posizione di vicinanza al Sudafrica. La
lotta, l'addestramento e 1'attivazione del Movimento di
liberazione in Congo sarebbero serviti a tutti gli altri paesi e
in modo particolare al Sudafrica. Questa era la sua idea.
Soprattutto nella riunione con i dirigenti dei movimenti di
liberazione africani, dove lui sostenne con enfasi che invece
dell'addestramento a Cuba e dell'invio di fondi, come avrebbero
voluto loro, occorreva addestrarsi direttamente in Congo, che era
vicino.” (cfr. pag.68). - sull’addestramento e formazione quadri: “La
situazione era sempre più critica e il progetto di formare un
esercito, con il relativo potenziale di uomini, armi e munizioni,
si stava sfaldando fra le nostre mani. Ancora impregnate di non so
quale cieco ottimismo, ero incapace di vedere la realtà e nel
fare il resoconto del mese di settembre, scrivevo: Tutti i miei
sforzi devono concentrarsi sul creare una colonna indipendente,
perfettamente armata e ben rifornita, che costituisca una forza
d’assalto e al tempo stesso un esempio per gli altri; se
riusciremo a ottenere ciò, la situazione cambierà in modo
sostanziale, in caso contrario sarà impossibile organizzare un
esercito rivoluzionario; la scarsa qualità dei comandanti lo
impedisce.” (cfr. pag.193) -sulla disciplina come elemento necessario,testimonianza di Alexis: “I cubani erano disciplinati. Tatu diceva: questo non si può fare, e
nessuno si azzardava a controbattere. Se noi mangiavamo yucca,
tutti dovevano mangiare yucca; se c’era del riso, era riso per
tutti. Se non c ‘era niente, allora niente per nessuno. Era
sempre così. Ne restai molto impressionato. Se il Che diceva:
oggi tu devi restare qui e non puoi indietreggiare, i cubani non
facevano un passo indietro.” (cfr. pag.213). Di
contro, Guevara si accorge immediatamente dell’indisciplina
delle forze che dovevano animare la resistenza interna, aggravata
da alcuni fattori che impedivano lo sviluppo della lotta in senso
popolare: l’inettitudine dei comandanti, la scarsezza dei quadri
e la latitanza della
coscienza di classe, la divisione fratricida tra fazioni
contrapposte (non caratterizzata ideologicamente e politicamente,
ma causata da prestigio personalistico), le superstizioni, da cui
comunque bisognava partire per radicare lo spirito rivoluzionario.
Diventava dunque il superamento di questi fattori soggettivi, il
realistico programma del contingente cubano, nella speranza che
l’esempio potesse servire da sviluppo qualitativo e quantitativo
delle forze soggettive per la rivoluzione, e per una resistenza
che si trasformasse, appunto, in guerra popolare. Per cui
l’esito delle missioni guidate da Guevara, in Congo e in seguito
in Bolivia, dove le condizioni soggettive per un piano
rivoluzionario erano ancora più arretrate, non può essere il
metro di giudizio a posteriori delle idealità e programmi che il
combattente comunista elaborava per poi trovare una coerenza
nell’azione. Valga la testimonianza di Videaux sugli elementi
ora presi in considerazione: “Penso
che Tatu, quando fece il primo giro in Africa, avesse giudicato,
nonostante tutte le difficoltà esistenti, che in Congo ci fossero
le condizioni oggettive. C’erano certe situazioni che però
andavano contro tali condizioni: ad esempio che i dirigenti si
trovassero fuori dal paese; mentre alcune erano favorevoli: la Non di spontaneismo o di velleitarismo, quindi, bisogna parlare, ma di internazionalismo proletario operante. Semmai uno dei punti più controversi della prassi guevarista, dovrebbe essere più al centro dell’attenzione analitica, rispetto ai tradizionali canoni del marxismo—leninismo: può una rivoluzione svilupparsi (e vincere se si trasforma in guerra popolare) solo sul piano politicomilitare, con i1 massimo dell’organizzazione e della disciplina, nonché con un’adeguata preparazione dei quadri che costituisca l’avanguardia trainante della masse? In breve, rispetto all’analisi classica marxista, pur creativamente sviluppatasi dopo la Rivoluzione bolscevica del ‘17 e con la conseguente opera del leninismo, la classe proletaria che deve assumere la guida delle lotte rivoluzionarie (in difensiva resistenziale o in controffensiva) perché la rivoluzione si incammini verso la prospettiva socialista, come si connota in un paese del ‘lumpensviluppo’, coloniale o semicoloniale? E’, cioè, il tema dell’analisi sociale, che, nella prassi rivoluzionaria comunista, lega fattori oggettivi e fattori soggettivi. Come ha notato Guillermo Almeyra, che pure ha cercato tutti i punti di contatto tra correnti trotskiste e elaborazione guevarista (l’originale elaborazione del ‘Che’, senza le interpolazioni del Debray), anche su questo punto le differenze sono sostanziali. I gruppi ‘posadisti’ brasiliani, peruviani e soprattutto argentini ed uruguagi, il Partito operaio rivoluzionario boliviano, erano gruppi settari testimoniali e solo propagandisti, che non si ponevano il problema dei contadini, maggioranza della popolazione latinoamericana. Invece “Guevara” proprio a differenza di Trotsky — “credeva che il motore della rivoluzione sarebbero stati i contadini ribelli, e non gli operai (..) integrati nel capitalismo e più o meno privilegiati. Influenzato dall‘esempio argentino, credeva che gli operai, come i sindacati peronisti, non potessero sfuggire al dominio burocratico. Di qui il suo interesse per la rivoluzione cinese”. (5) Dunque Mao, leader e teorico della “guerra di popolo”, era un consistente punto di riferimento dell’azione guevarista, sebbene con una lettura “in traduzione” nelle specifiche condizioni del continente latinoamericano; e dopo i1 1964, Vo Nguyen Giap, il grande comandante militare vietnamita, croce dei francesi prima e degli statunitensi dopo. I contadini furono mossi, nella rivoluzione cubana, e dalle oggettive barbare condizioni in cui li aveva costretti la dittatura di Batista, e dall’esempio dei “barbudos” nelle zone liberate: “Nella nostra piccola guerriglia di estrazione cittadina (...) il popolo aveva dimenticato la paura, si era deciso a lottare, imboccava senza esitazioni la via della propria redenzione. Su questo cambiamento incideva la nostra politica verso i contadini e i nostri trionfi militari, che ci mostravano già come una forza invincibile nella Sierra Maestra. Posti di fronte all‘alternativa, tutti i contadini scelsero la strada della rivoluzione. Il cambiamento di carattere(...) appariva ora in tutta la sua chiarezza, la guerra era un fatto, doloroso certo, ma transitorio, una condizione non definitiva a cui l’individuo doveva adattarsi per sopravvivere.” Pur
con le necessarie differenziazioni, nello scritto di Mao "Problemi della guerra e della strategia” del novembre 1938 —
costituivano parte delle conclusioni presentate alla sesta
sessione plenaria del sesto Comitato Centrale del Partito
Comunista Cinese — i celebri 18 punti per la funzione strategica
della guerra partigiana, sembrano essere i1 materiale punto di
riferimento del combattente proletario, trait d’union tra lo
stesso Mao, Che Guevara e Giap (fasi difensive, di equilibrio e di
controffensiva; “7. massimo sviluppo del partito comunista (...) per
organizzare in ogni villaggio una cellula di partito; (..) 11.
miglioramento delle condizioni di vita del popolo in zone quanto
più ampie possibili”, ecc..). Guevara presenta l’edizione
spagnola del libro del generale Vo Nguyen Giap “Guerra di popolo, esercito di popolo”, nel 1964, convinto che
l’opera “affronta
problemi di interesse generale per quella parte del mondo che è
in lotta per la propria liberazione. Problemi che possono così
riassumersi: la fattibilità della lotta armata in situazioni
particolari in cui siano falliti i metodi pacifici di lotta di
liberazione, le modalità di essa in luoghi con grandi estensioni
di terreno favorevole alla guerriglia e con popolazione in
maggioranza o in misura rilevante contadina.” E per Giap,
come per Mao, grande era stato l’esempio e l’elaborazione
leninista sull’organizzazione militare e il suo rapporto con
le classi sociali: “(...)
una forza armata rivoluzionaria (è) formata da tre componenti: a)
il
proletariato e i contadini armati; b) i distaccamenti
d’avanguardia organizzati, formati dai rappresentanti di queste
classi; c) le unità dell’esercito schieratosi con il popolo. La
rivoluzione ha potuto edificare in tal modo una forza armata che
comprendeva essenzialmente le larghe masse operaie e
contadine
armate combattenti sotto la direzione del partito comunista,
funzionanti da forza d’urto della spinta rivoluzionaria delle
masse. Questa forza ha avuto un ruolo determinante nella vittoria
della rivoluzione di febbraio
poi della Rivoluzione d’Ottobre” (6) Qui è uno dei
punti dirimenti: la spinta rivoluzionaria, messa in movimento
dalla situazione oggettiva, è diretta e organizzata dal partito
comunista, per cui si crea
la necessaria “forza d’urto” che decide le sorti del
rivolgimento rivoluzionario. Dunque, leninisticamente,
1‘insurrezione può diventare
rivoluzione, ma la presenza e l’attività disciplinata di un
partito che rappresenti le masse popolari e sia guidata da quadri
dirigenti d’avanguardia, è condizione non dello scoppio, ma
dell’esito della rivoluzione. Prima, è semmai condizione
soggettiva
che accelera e dirige l’insurrezione, crea e rafforza la
coscienza di classe, spinge verso obiettivi avanzati: costruisce
un processo rivoluzionario, pronto ad essere l’avanguardia
dell’eventuale punto di rottura con il sistema sociale
dominante: “Essere
un partito d’avanguardia significa stare alla testa della classe
operaia nella lotta per la conquista del potere e saperla inoltre
condurre al potere guidandola per scorciatoie. É questa la
missione dei nostri partiti rivoluzionari, e
1‘analisi deve
essere profonda ed esauriente per non incorrere in errori”. Fermo
restando l’”analisi differenziale”, l’obiettivo strategico
del partito rivoluzionario non può non essere la presa del
potere. Citando la Seconda Dichiarazione dell’Avana del 1962,
dopo che i1 25 gennaio di quell’anno la Conferenza dei
cancellieri latinoamericani riuniti a Punta del Este aveva espulso
Cuba dall’OSA, e che concludeva la conferenza dei popoli,
Guevara sottolinea un passaggio importante: “Le
condizioni soggettive di ciascun paese e cioè i fattori
coscienza, organizzazione, direzione, possono accelerare o frenare
la rivoluzione, a seconda del suo grado maggiore o minore di
sviluppo, ma presto o tardi in ogni periodo storico, quando le
condizioni oggettive maturano, la coscienza si acquisisce,
l’organizzazione si fa, la direzione si forma e la rivoluzione
ha luogo. (7) Si appalesa qui il grande ruolo che il Che
attribuisce alla forza delle condizioni oggettive (non viceversa)
per cui, anche in assenza della compiuta strutturazione di un
partito d’avanguardia, con tattica e strategia coerenti e volto
alla conquista del potere politico, che spinga e adegui la
coscienza rivoluzionaria delle masse, questo ruolo può essere
assolto dall’esempio rivoluzionario, purché poi tutte le
tessere del mosaico (le condizioni oggettive costituiscono il
terreno sociale dello scontro, l’esempio rivoluzionario forma i
quadri e organizza 1‘insurrezione nella massima disciplina e
unità d’azione, il partito rivoluzionario guida le masse
popolari agli obiettivi avanzati della presa del potere politico
e al socialismo, la guerra “de guerrillas” si trasforma in
un più generale rivolgimento rivoluzionario con basi di massa) si
incastrino correttamente nelle specifiche condizioni storiche
determinate. In questo senso, il giudizio di G.Almeyra, secondo
cui “si possono anche
vedere il peso eccessivo che lui
- e dirigenti cubani - attribuivano al fattore cosciente,
all’ ‘esempio', al ruolo soggettivo, alla volontà
rivoluzionaria e l‘insufficiente padronanza delle
caratteristiche storiche, etniche,
culturali, dei paesi caratterizzati dallo sviluppo disuguale e
combinato, nei quali coesistono settori proletari (come i minatori
boliviani) o intellettuali politicizzati (come nel Congo) e altri
marcati da rapporti precapitalistici e segnati da motivazioni
etniche e da forme di pensiero magico” (8), dovrebbe quanto
meno essere corretto da un’importante considerazione: che
le condizioni oggettive sono comunque preminenti e che le
condizioni soggettive non si creano dal nulla, ma dalla disciplina
e dall’organizzazione, seppure surrogando in prima istanza il
ruolo dei partiti comunisti d’avanguardia, comunque favorendone semmai
la formazione, lo sviluppo e/o la correzione di linea. Il
leninismo di Guevara, dunque, è molto più evidente che non
letture tutte basate su elementi “coscienza soggettiva” e
“rivoluzione permanente”, astratti e non inquadrati
nell’interpretazione marxista—leninista propria del Che. Certo,
e anzi, proprio per questo, non esiste il partito che costituisce
esso stesso il “punto di rottura”, con schemi prefabbricati e
con la rigidità ideologica, avulso dal reale movimento delle
masse. Per cui è da questo punto di vista che va considerato il metodo
di lotta guevarista, dopo la vittoria con Fidel sulla Sierra
Maestra: pur su un impianto fortemente leninista
dell’elaborazione, il Che prova ad intrecciare correttamente,
nell’analisi e dunque nell’azione, il rapporto tra
organizzazione militare, formazione dei quadri e individuazione
delle forze motrici rivoluzionarie, in paesi a forte connotazione
contadina e scarsa presenza quantitativa proletaria in senso
stretto. L’assenza e/o l’insufficienza di un partito comunista
che dirigesse le lotte dal punto di vista politico, erano in
pratica sostituiti dal volontarismo soggettivo, dall’esempio in
funzione della formazione della coscienza di classe. E questo,
probabilmente, era ben presente e calcolato nella testa del Che,
se è vero che continuamente egli ritorna sulla reale possibilità
di esito negativo ( e perdita
della sua stessa vita) sul breve periodo; coscienza, cioè, di
preparare un‘accelerazione del processo rivoluzionario contando sulle
oggettive contraddizioni sociali, non l’insurrezione né i1
punto di rottura, né l’immediato impeto rivoluzionario. Compito
più che di supporto, nelle sue esperienze, in particolare
l’ultima boliviana, di surroga dei compiti del partito comunista
di quadri e legato alle masse popolari. Questa “insufficienza
soggettiva” poteva essere colmata? no, ma potevano essere
sviluppate le condizioni perché si colmassero. I partiti
comunisti,
come quello cubano durante e immediatamente dopo la rivoluzione,
potevano essere spinti ad adeguarsi non ad un marxismo—
leninismo di facciata, liturgico nel formulario, ma vuoto nella
sostanza, senza profondi rapporti con le masse, ma al contrario
leninisti nella loro azione politica e strategica. Una sfida e scommessa ardui: ma per un comunista, si sa, la rivoluzione non è
mai “un pranzo di gala”. Comunista non da tavolino, ma
coerente combattente proletario: “… e
ci toccò scalare i monti. Alcuni compagni svenivano. Il Che era
il primo a salire, nonostante l‘asma. Quell’uomo non
aveva limiti,
faceva per primo quel che voleva facessero gli altri. Beveva
il
tè senza
zucchero e diceva:”Che buono.” Più passano gli anni più ci si rende conto di che razza d’uomo fosse.” (dalla
testimonianza di ‘Nane’ nel diario congolese). Il 12 agosto
1965 il Che scrive un messaggio ai combattenti, in cui ribadisce
con forza quali comportamenti debbono adottarsi da parte dei
cubani per legarsi alle finalità politiche, tattiche e
strategiche della missione congolese, con profondo realismo e
senza i tanto decantati scatti utopici: “L'indisciplina
e la mancanza di spirito di sacrificio sono le caratteristiche
dominanti di tutte (queste) truppe guerrigliere. Naturalmente
con truppe simili non si vince
alcuna guerra.” Ma per capire la filosofia dell’azione guevarista fino in
fondo, non si potrà mai disgiungere questo realismo dalla
speranza, speranza non fideistica che ogni comunista conseguente e
coerente deve possedere nella trasformazione rivoluzionaria e che
non si aspetta “dal cielo”, ma si rende concreta con
l’esempio, la modestia e l’amore rivoluzionari, finalizzati
alla creazione e formazione di veri combattenti per il socialismo,
che sappiano cogliere e sviluppare positivamente le contraddizioni
dell’imperialismo: “La
nostra missione è aiutarli a vincere la guerra. (...) L’ansia
di insegnare deve prevalere in tutti noi ma non in maniera
pedante, guardando gli altri dall‘alto in basso, bensì facendo
sentire il nostro calore umano negli insegnamenti che impartiamo.
La modestia rivoluzionaria deve
guidare il lavoro politico e deve essere una delle armi
fondamentali, unendo quello spirito di
sacrificio che dovrebbe essere di esempio non solo verso i
compagni di qui, ma anche verso i più deboli fra noi”. Realismo
e virtù rivoluzionarie, una grande lezione di didattica operativa
del marxismo e del leninismo, tutt’uno con la sua concezione
generale che un combattente proletario deve possedere: bisogna
amare il popolo per essere amati dal popolo. Più che romanticismo
visionario, un grande insegnamento maoista. Oltre
il mito dell’utopia, dunque: perché il modo migliore di rendere
vivo l’esempio di Ernesto Guevara, non è quello di rinchiuderlo
in schermi pregiudizievoli né accarezzare solo la sua immagine
così come recepita dall’immaginario collettivo giovanile, che
pure va alimentata con la giusta coscienza, quella di classe; ma
individuare nell’analisi una corretta prassi per le
trasformazioni rivoluzionarie dei nostri tempi e del XXI secolo
prossimo venturo, magari andando a rileggere, studiare e
rimeditare la formidabile teorizzazione di tutti quegli
intellettuali comunisti latinoamericani (penso all’esempio di
Ander Gunder Frank) e i contributi che hanno apportato
all’analisi sull’imperialismo e che troppo presto e in fretta
sembrano essere stati dimenticati. Come
ha annotato Santarelli, in un suo intervento convegnistico, poi
riportato sulla rivista “Latinoamerica” del gennaio—marzo
1991, quello del ‘Che’ è
“un marxismo, insomma, sostenuto dal gusto della libertà e
del dibattito, da un grande
slancio per il rinnovamento della società e della cultura, della
ricerca dell‘azione diretta e della sperimentazione. (...)
All’America Latina si può e si deve guardare, senza
atteggiamenti né esotici né estremistici, al contrario con
occhio e spirito realistico, come a una posizione avanzata nella
lotta che si svolge, oggi,
e
si svolgerà domani su scala
mondiale”. In
quest’ottica, ci pare che possa essere continuato i1 sentiero
tracciato da questo grande comunista del nostro secolo, che nessun
Barrientos potrà avere la pretesa di fermare in una qualsiasi
‘Quebrada del Yuro’ del mondo. NOTE 1)
Di Roberto Massari si veda il testo fondamentale “Che
Guevara--
pensiero
e politica dell’utopia”, Edizioni Associate, 1987 e inoltre
“Conoscere il Che”— (a cura di Roberto Massari) — con
testimonianze di Castro, Sartre, Ben Bella, Gades, Granados e
inediti di Guevara — Datanews,1988. Una delle iniziative più
importanti invece della Erre Emme è stata la pubblicazione degli
“Scritti scelti” di Guevara, Roma, 1993. Inoltre, per i tipi
della stessa casa editrice, cfr. C.Tablada: “Guevara — il
pensiero economico”, con introduzione di Fidel Castro (1994) e
R.Massari/F.Mantinez y otros: “Guevara para hoy” (1995). 2) Da qui il giudizio veritiero, nonostante la presa un pò
“biblica” e le metafore religiose, di Eduardo Galeano,
giornalista uruguagio, autore di reportage su Cina e America
Latina, in un articolo apparso per la prima volta su “Monthly
Review”, nel marzo del
1966 e ripreso dalla stessa rivista nel numero di ottobre 1969 con
il titolo “Che Guevara, il Bolivar del nostro tempo?”: “Era
dedito totalmente – “coma
si deve” — al difficile compito di costruire il socialismo a
Cuba. Era il più austero di tutti i capi, al punto di eguagliare,
in capacità di sacrificio, i cristiani delle catacombe.
Convinto com‘era che la mistica del socialismo - il cammino e la
fede degli uomini nel nuovo mondo - potesse costituire il movente
dello sviluppo, rifiutava l’uso eccessivo di incentivi materiali
e dei sistemi di pagamento che avrebbero potuto dare ad ognuno la
speranza di “diventare un Rockefeller”. Si sentiva offeso
della possibilità che, sotto la protezione della legge del
valore, da lui rifiutata, potesse verificarsi un ritorno alla
società capitalista ( altri casi lo dimostrano). Su questo
argomento era duro, inflessibile. , cfr. ivi,
pag.21. 3)
Il testo, nel quale i1 diario inedito africano del Che è inserito
(frammenti manoscritti o dettati ricomposti) si intitola infatti
significativamente “L’anno in cui non siamo stati da nessuna
parte”, e in cui possono leggersi, seguendo il filo cronologico
degli avvenimenti, testimonianze di straordinaria importanza di
alcuni dei protagonisti di quell’avventura congolese, primi fra
tutti Victor Dreke (‘Moja’), Pablo Rivalta, Erasmo Videaux,
comandanti guerriglieri e uomini di fiducia di “Tatu”
(nomignolo affibbiato a Guevara in Congo), ma anche di Antoine
Godefroi (detto “Chamaleso—Tremendo Punto”) rivoluzionario
congolese che stabilì il contatto tra il movimento di liberazione
nazionale e il contingente cubano, e in cui compaiono nitidamente
le figure di Harry Villegas detto “Pombo”, inseparabile
braccio destro del Che fino a tutto i1 1967, di José Maria
Martinez Tamayo, ribattezzato “M’bili” (“due volte”),
infaticabile guerrigliero cha troverà poi la morte in Bolivia, di
Herrera y Garrido detto “Genge” oppure di Pio Pichardo e Moro
Perez (che non torneranno più), di Fernandez Mell, Sanchez
Bartelemy, Terry Rodriguez e di altri ancora. Il ritrovamento e la
pubblicazione del diario (che era nell’archivio del Che a Cuba
in forma dattiloscritta con i1 titolo “Passaggi della guerra
rivoluzionaria. Il Congo”) si deve ai curatori del volume in
questione, Paco Ignazio Taibo II, storico messicano, e Froilan
Escobar e Felix Guerra, giornalisti cubani, edito in Italia
dall’ed. Ponte alle Grazie, 1994, con l’introduzione di
P.Cacucci. 4)
Esempi delle illazioni che circolarono:
—testimonianza di Elmar May: “Secondo ‘France Presse’, il
Che e Fidel si erano presi a revolverate durante una lite, e il
Che era rimasto ucciso. Il quotidiano peruviano ‘La prensa’
mise in giro la voce che il Che era stato eliminato dai sovietici
a causa delle sue tendenze filocinesi.” —testimonianza di
Gilly: “Fidel Castro, secondo il giornale trotzkista di
J.Posadas, teneva nascosta la morte del Che.” (cfr. ivi,
pag.194) 5)
Cfr. G.Almeyra/E.Santarelli: “Guevara —
Il
pensiero ribelle”, Datanews, 1993, pag. 35 6)
Cfr.Vo Nguyen Giap: “Masse armate ed esercito regolare”,
tr.it.Teti, 1975, pag.27. Le citazioni di Guevara in “Scritti,
discorsi e diari di guerriglia”, Einaudi, 1969, pp.279 e
445/446; l‘articolo di Mao in “Opere”, vol.7 (1938/1940),
ed. Rapporti Sociali, 1992, pag.65. Il presupposto di tutti è
profondamente leninista e del suo sviluppo creativo e combattente
del marxismo: “Irriducibilmente
ostile a ogni formula astratta, a ogni ricetta dottrinale, il
marxismo esige attenta considerazione della lotta di massa in
atto, che, con lo sviluppo del movimento, con l‘elevarsi della
coscienza delle masse, con 1‘inasprirsi delle crisi economiche e
politiche, suscita sempre
nuovi e più, svariati metodi di difesa di e attacco. Non rinuncia
quindi assolutamente a nessuna forma di lotta,
non si limita in
nessun caso a quelle
possibili ed esistenti solo in un determinato momento,
riconoscendo che inevitabilmente, in
seguito al modificarsi di una determinata congiuntura sociale,
ne sorgono delle nuove, ancora ignote agli uomini politici di un
dato periodo. Sotto questo aspetto il marxismo impara, per così
dire, dall’esperienza pratica delle masse, ed è alieno dal
pretendere di insegnare alle masse
forme di lotta escogitate a tavolino dai ‘sistematici’.(..) In
secondo luogo, il marxismo esige categoricamente un esame storico
del problema delle forme di lotta”. Cfr. Lenin, “La guerra
partigiana”, in Proletari,
n. 5, settembre 1906, e più complessivamente i saggi “Dalla
difesa all’attacco” (1906), “Programma
militare della rivoluzione proletaria” (1916), “Il
marxismo e l’insurrezione” (1917), considerati studi necessari
preliminari ed indispensabili per
l’analisi
delle situazioni rivoluzionarie e le conseguenti forme di
lotta anche da Pietro Secchia: “La
sua tesi è sì, che occorre studiare seriamente i problemi, ma non
perdersi in troppi schemi e in troppi piani, soprattutto agire,
poiché il moto lo si prova camminando (credo che balzi qui
evidente la consonanza tra l’interpretazione leninista di
Secchia e Guevara, (ndr) (..) (il) saggio sulla “guerra
partigiana” (.) è un vero e proprio gioiello di arte militare e
nel tempo stesso di direttive politiche sulle diverse forme di
lotta. (..) Senza alcuna pretesa, avverte, di imporre alcuna forma
di lotta “da noi inventata”, né di voler risolvere a tavolino
problemi che solo nel corso stesso della lotta partigiana
troveranno la loro soluzione. Saper imparare dalla vita, dalla
lotta e dalle masse è il consiglio che ripete costantemente
mentre conduce una lotta implacabile contro ogni forma di
schematismo. Al pari di Marx, Lenin pose sempre l’iniziativa
storica delle masse al di sopra di tutto (..)” cfr.
P Secchia, “Lenin e la scienza militare”, in Il Calendario del
Popolo, maggio 1971, pag. 2595. 7)
Cfr. Che Guevara: La guerra di guerriglia è un metodo,
in “Cuba socialista”, n.25, settembre 1963, raccolto in Scritti,
cit., pag.428/429.
Il saggio è basato su questi importanti presupposti: “La guerra di guerriglia è stata utilizzata un numero incalcolabile
di volte nel corso della storia, in condizioni diverse e con fini
diversi.(...) Nella polemica in corso si suole criticare quelli che
vogliono fare la guerra di guerriglia adducendo che si dimenticano
la lotta di massa, come se si trattasse di metodi contrapposti. Noi
rifiutiamo la concezione implicita in questa posizione: la guerra di
guerriglia è una guerra
di popolo, è una lotta di massa. Pretendere di fare questo tipo di
guerra senza l’appoggio della popolazione, significa andare
incontro a un disastro
inevitabile. La guerriglia è l’avanguardia combattente del
popolo, situata in un luogo determinato
di un certo territorio, disposta
a sviluppare una serie di
azioni
di guerra tendenti al solo fine strategico possibile: la
presa del potere. Questa guerriglia è appoggiata dalle masse
contadine e operaie della zona e di tutto il territorio in questione. Senza queste premesse la guerra di
guerriglia è inammissibile”. ivi, pag. 425/427.
|
||
"I nostri storici devono essere coscienti della grande responsabilità del loro lavoro; essi non sono solo degli studiosi, essi sono in primo luogo dei combattenti della classe operaia, dei marxisti-leninisti militanti i quali, scrivendo la storia, assolvono una funzione importante di partito. Lo storico marxista deve ricercare la verità, distruggere le false concezioni, far risaltare la superiorità del materialismo storico quale strumento di orientamento e guida per l'azione"
Arturo
Colombi, 1954
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||